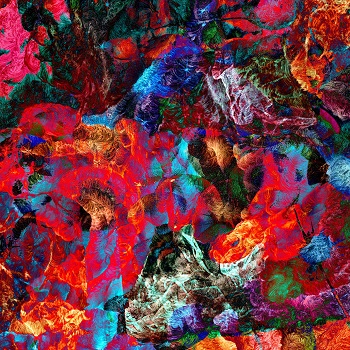Scrivendo da un bel po’ di tempo di musica mi capita spesso di chiedermi: ma la gente ci capirà qualcosa in quello che scrivo? Perché è facile, per me che ascolto un disco, provare qualcosa, che sia un’emozione o un piacere più dovuto alla costruzione del momento musicale, ma poi trovare le parole giuste per trasmetterlo è un gran casino. Non sono un grande lettore di critica musicale (anche se ci sono eccezioni altamente meritevoli), per cui ignoro od ho solamente un’infarinatura di come abbiano risolto il problema altri prima di me: la mia soluzione è affidarmi perlopiù all’istinto, ma chissà se capite cosa intendo quando parlo di “ventate elettroniche che sgorgano qua e là e improvvise sferzate percussive a buttarla in caciara ma senza mai esagerare“, o cosa vi appare alle orecchie quando descrivo cosa sta “fra voci modificate elettronicamente e suoni che, come in una megalopoli futuristica, mischiano freddi ritmi sintetici a pulsioni esotiche“. Ho persino scritto una recensione come se fosse la sintesi di una stagione calcistica (mutuando il titolo dell’articolo, come in questo caso, dal capitolo L’assassinio di John Fitzgerald Kennedy considerato come una gara automobilistica in discesa in La mostra delle atrocità di James Graham Ballard)! Questo aiuta magari narrativamente, ma poi a chi legge arriva l’idea del suono in qualche maniera?
Questa domanda mi si è riaffacciata in testa mentre pensavo a come iniziare a parlare di Non nella Enne non nella A ma nella Esse di Mariana Branca, autrice che ho scoperto tramite lo splendido racconto Angelina no pubblicato sul numero 4 della rivista Quaerere. Perché di musica parla il romanzo d’esordio dell’autrice, scritto in nove mesi fra il 2016 e il 2017 e arrivato alla pubblicazione con Wojtek Edizioni, anche tramite il Premio Calvino di cui è stato finalista, solo nel 2022. Parla di musica e parla con la musica, con il ritmo fisso agli ottanta bpm delle canzoni dell’enfant prodige della scena elettronica Nicolas Jaar, di cui il romanzo è una sorta di biografia. Lo è nei termini in cui racconta il suo percorso artistico e di vita, dall’adolescenza passata a manipolare suoni e correre in bicicletta ai concerti in enormi auditorium in giro per il globo passando per il college e le esperienze nella scena dei club newyorkesi, ma i contorni degli eventi sono confusi e l’autrice sembra disinteressarsi della precisione didascalica se non quando deve stilare elenchi di walkman o la componentistica presente nella prima versione del programma Reason, perché a Branca interessa l’emozione e non la precisione.

Io di Nicolas Jaar non avevo mai sentito niente, e mi sono approcciato alla sua musica solo dopo aver finito il libro. Il suo brano che più assocerei all’esperienza provata durante la lettura, a posteriori, è Swim, liquidità sonora che si trasforma velocemente in esperienza ritmica da dancefloor in continua mutazione che sfocia in territori tribalistico-spirituali nei vagiti finali dei suoi tredici minuti di durata, ma la canzone (contenuta nel disco Nymphs) è stata pubblicata nella seconda metà del 2016, di poco antecedente l’inizio della stesura del libro. Può aver Branca mutuato la sua idea da quelle note? Non lo so, e forse la stesura è stata influenzata da un medley di composizioni dell’allora ventiseienne Jaar, ma in quella traccia c’è tanto dell’esperienza ipnotica e trascinante che le parole dell’autrice creano, di quell’atmosfera vagamente elitaria ma non escludente in cui il musicista sguazza con il suo compagno e biografo Andres F. Rodriguez, la voce narrante che ci accompagna lungo il percorso.
Così, esattamente così erano i suoi occhi, i suoi occhi blu pieni di blueprints, di immagini future, i suoi occhi cianografici come una carta lucida sensibilizzata con ferrocianuro di potassio e citrato di ferro ammoniacale, sulla quale, appena a contatto con l’acqua, apparivano tratti bianchi sul fondo blu scuro. Di notte, ancora più di notte che di giorno, ne erano pieni, di immagini future, e faceva fatica a mettere a fuoco per leggere, allora lui guidava e cantava Leonard Cohen e io leggevo tutte quelle informazioni sul Marcy Hotel e fu così che conoscemmo Nino.
Non nelle Enne non nella A ma nella Esse, pag. 47
Ma chi è Rodriguez? Amico, fratello, gemello, figura enigmatica che fluttua nella vita di Jaar in maniera simbiotica, partecipe di tutte le sue esperienze eppure inesistente (oppure no? Una ricerca su Google non mi restituisce niente sulla sua vita e la sua presenza nel creato tangibile). Del suo entusiasmo si permea tutta la narrazione, spandendo sugli eventi la luce della predestinazione di modo che tutta la vicenda suoni estatica, gioiosa, la colonna sonora di un mondo in cui nulla di male può accadere e tutt’al più può sopraggiungere della malinconia, caratteristica unica di Jaar e non sua, a velare lievemente l’atmosfera solare che avvolge i personaggi anche quando piove, come fuori dalla centrale elettrica quando un’acquazzone fa da punto di passaggio per passare oltre.
In Non nella Enne non nella A ma nella Esse anche gli ambienti creano un suono, un’atmosfera. La centrale elettrica in cui Jaar e Rodriguez si avventurano nei primi esperimenti sonori, la casa del musicista in cui il signor Jaar e Evelyne (Evelyne Meynard, la madre designer) ballano sotto lo sguardo incantato dei due, l’università che frequentano come meteore distanti dalla massa e ad essa capaci di adeguarsi e il Marcy Hotel dove entrano in contatto con la scena elettronica newyorkese, luoghi che hanno una loro frequenza distinta in cui le esperienze sono vibrazioni, suoni onirici e dilatati in cui lasciar andare pulsioni e amori giovanili che si mischiano con le luci di dancefloor in cui un sfogarsi e poi sdraiarsi estaticamente, avvolti dal suono. La vita di Jaar scorre inarrestabile come la corrente di un fiume, non impetuosa ma docile e decisa, incapace di trovare ostacoli, come una melodia che ti si ficca in testa e non esce più e che non maledici per la sua pervicacia, ma benedici per il modo in cui accompagna i momenti migliori, in cui getta luce nuova anche su quello che fino a poco prima creava solo ombre.
Ebbe, come tema d’esame, Israele e la Palestina, forse perché la famiglia Jaar arrivò a NYC dalla Palestina più o meno intorno al 1920, e il suo primo istinto fu quello di guardare i segnali di stop nella zona ovest. I palestinesi e gli israeliani avevano lo stesso segnale di stop, una mano con le dita inspiegabilmente incollate tra loro, una sagoma in cui non sono distinguibili le dita, su un fondo rosso ottagonale. L’immagine lo intrigava, sembrava tanto futuristica quanto antica, voleva dire che Israeliani e Palestinesi avevano la stessa idea di mano, senza dita, lo stesso modo di dire fermati senza usare le parole. Per quanto si volessero separare, distinguere l’uno dall’altro, i due popoli usavano lo stesso identico disegno-segno-segnale per dire che ti dovevi fermare. Che oltre non potevi andare. Così aveva fatto cinque adesivi della misura di un segnale di stop americano e mi disse: appiccichiamoli a Providence. Ne attaccammo solo uno, gli altri decidemmo di applicarli a NYC, da qualche parte intorno la Occupy Wall Street.
Non nella Enne non nella A ma nella Esse, pag. 65
Anche l’amicizia è un suono, note limpide e solari come il rapporto fra Jaar e Rodriguez, una simbiosi che crea un modello di mascolinità ideale e auspicabile, totalizzante ma non esclusivo, e poi il rapporto fra loro e il mondo, uno scrigno pieno di opportunità in cui nessuna ombra sembra riuscire a entrare, perché Il ritmo vitale della scrittura di Branca riassume e crea un’esistenza in cui il conflitto è limitato al minimo indispensabile senza che se ne avverta la mancanza. Il duo e gli amici che ruotano loro intorno, dal Nino amante di Leonard Cohen e di Jean-Luc Godard al Dave Harrington che di Jaar è sodale nei Darkside, attraversano ambienti e situazioni permeati di gioia e curiosità, alla ricerca del bello e dal bello trasfigurati, un bello che si manifesta nelle numerosissime suggestioni che continuano a vagare nella narrazione, dalle foto di Gordon Matta-Clarck all’arte a tutto tondo di Man Ray fino al Nastro che cambia tutto, la musica di Ricardo Villalobos che… ma facciamolo dire a Branca
Quella volta, invece, che il Nastro si era inceppato, ingarbugliato, che gloglottava un suono extraterrestre, un po’ sublime, quella volta nel suo sguardo di fondale marino avveniva una desquamazione, i suoi occhi si stavano spiccicando di dosso la cornea, si spogliavano per una specie di muta esistenziale, trasformandosi in due diamanti arrotondati, centinaia di schegge di flex nel bianco albuminoso degli occhi. Erano due sfere di polveri metalliche in procinto di schizzare, e dentro un’espressione fumosa, vacua, perduta, lontanissima; al suono alieno solidali, penetrati in esso, da esso penetrati. Animisti, animali.
L’ho guardato e guardandolo sono sparito, entrato in un tunnel fatto di LSD, come fossi scivolato nell’ipnosi; il suono ingarbugliato del Nastro in sottofondo, a ripetizione, e più lo guardavo e più capivo, lo sapevo. Era come una volta ascoltando Bonga, la canzone Mona Ki Ngi Xica: gli era preso un colpo, una specie di collasso. Si era seduto, buttato, sfinito, e alla fine della canzone aveva detto che si sentiva amato. Mona Ki Ngi Xica, Il Bambino Che Mi Lascio Dietro, e io piangevo, in segreto zitto muto.
Non nella Enne non nella A ma nella Esse, pg. 18/19
Non nella Enne non nella A ma nella Esse è narrazione musicale e musica incarnatasi (incartatasi?) in testo, contiene la capacità di descrivere con tutte le parole che servono melodie emozioni eventi e situazioni e trasformarle in suono. Quanto di questo è realtà? Molto sembra suggerire l’elenco di interviste a cui Branca ha attinto per creare la sua opera, poco sembra affermare la visionarietà emotiva con cui Rodriguez vive, e noi viviamo di conseguenza, la parabola ascendente di Jaar nell’Olimpo della musica, un Olimpo forse minore che mica stiamo parlando dei Rolling Stones ma che qui sembra l’apoteosi dell’esperienza vitale tutta. Ha importanza che tutto quanto narrato sia reale? No, e forse ne dovrebbe avere il fatto che io sia riuscito o meno a trasmettervi l’unicità dell’esperienza multisensoriale che dona la lettura di questo libro, a descrivere la musica delle parole anche solo in maniera simile a quanto riesce così facile in maniera tutt’altro che semplice a Mariana Branca: nel timore di non riuscirci ve lo dico chiaramente, questo è il miglior libro che mi sia capitato in mano da qualche anno a questa parte.
Ti è piaciuto questo racconto/articolo? Segui la pagina Facebook di Tremila Battute!
Scarica il numero Zero e il numero Uno della fanzine di Tremila Battute!