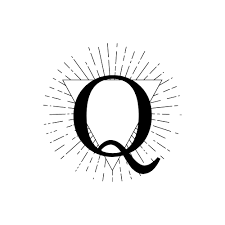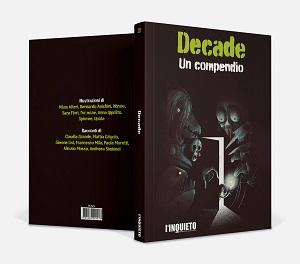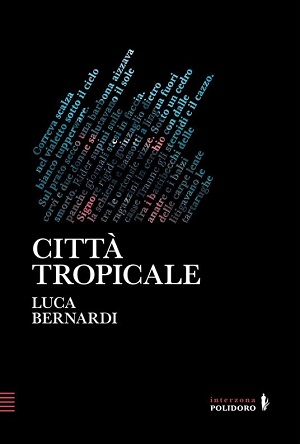Esiste un mondo in cui i contenuti originali di Netflix sono tutti del calibro di Roma di Alfonso Cuarón o The irishman di Martin Scorsese, ma non è questo. Non voglio strapparmi le vesti in nome del cinema d’autore, io i due film appena menzionati non li ho onestamente visti, ma sarebbe sicuramente preferibile un mondo come quello rispetto a uno dove La casa di carta è l’apice della produzione della grande N (metteteci pure Stranger things come alternativa) e molto del resto naviga in un mare di mediocrità ancora peggiore (non sono un grande fan de La casa di carta). Quando esce un film o una serie originale Netflix sono ormai portato a pensare, e non penso di essere l’unico, “quanto sarà sciatto/banale/scritto col pilota automatico? Più o meno di Spiderhead?”, e la risposta di solito è “di più o uguale”. Se poi i contenuti in questione vogliono affrontare qualche tematica sociale il rischio “lezione morale svogliata” aumenta a dismisura: immaginate Barbie (che per inciso mi è piaciuto) composto solo dallo spiegone anti-patriarcato prolungato per due ore, l’effetto rischia di essere quello. Quando la mia compagna mi ha proposto di vedere Fair play, film Netflix su una coppia in cui i legami di potere sono ribaltati pur in un’ambiente a livello di testosterone altissimo, il campanello di allarme è scattato a tutto volume: allo stesso tempo però abbiamo entramb* pensato che avremmo avuto qualcosa di cui (s)parlare, perciò ci siamo buttat* senza rete incrociando le dita.

Emily (Phoebe Dynevor) e Luke (Alden Ehrenreich) sono giovani, carini e ben occupati. Non vivono ancora in una villa con giardino, anzi il loro appartamento è nella media e non nella zona più lussuosa della città, ma lavorano entrambi per un fondo fiduciario e le opportunità di crescita e guadagno sono alte, soprattutto contando che gira voce che a un loro superiore sta per essere dato il benservito. Neanche il tempo di dirlo e voilà, con tipico sfogo distruttivo di chi ha dato tutto per l’azienda e ne riceve un calcio nel culo il superiore saluta i colleghi (usare l’asterisco per la sola Emily vi darebbe la falsa impressione che ci siano altre donne nell’azienda), e le voci che iniziano a girare sono sul sostituto: che possa essere Luke? La coppia fantastica sull’avvenire, ma rigorosamente lontano dall’ufficio, perché le regole aziendali vietano i rapporti interpersonali fra dipendenti: un bel problema contando che Luke ha dato ad Emily l’anello di fidanzamento e la mamma di lei non vede l’ora di dirlo a tutto il mondo, ma niente di insormontabile finché ci si ama e si fa fronte comune. O fino a quando non è Emily a essere promossa.

Che il lento logorio del rapporto di coppia sia il fulcro del film è chiaro già solo guardando il trailer, ma una produzione stanca e svogliata avrebbe mostrato tutto ciò che ci aspettiamo da un contesto in cui anche i muri urlano W IL PATRIARCATO e niente di più. Chloe Domont, regista e sceneggiatrice al suo esordio cinematografico dopo aver lavorato a svariate serie tv, riesce invece a lavorare di sottigliezze, sfumature di grigio (non le cinquanta che potete aspettarvi, anche se in giro vedo articoli che evidenziano il lato erotico della pellicola che sì, c’è, ma non è affatto preponderante) che rendono più credibili le vicende. L’insoddisfazione di Luke assume così i contorni, a seconda del momento, dell’invidia, della gelosia, della violenza e della megalomania, il tutto malamente trattenuto a esaltare le sue mancanze tanto di fidanzato quanto di maschio alpha; Emily non è la classica eroina in pericolo, nell’ambiente che si è scelta ci sguazza con maestria e solo qualche timido dubbio di non essere all’altezza (alimentato dai pessimi consigli di Luke), mostrando più volte comportamenti che fanno apparire lei come l’alpha della coppia e che risultano altrettanto discutibili; persino l’ufficio, un luogo dove quando appare un’altra dipendente mi sono ritrovato a esclamare “oh, ora c’è un team tutto al femminile” (prontamente redarguito dalla mia compagna), contiene dosi altissime di mascolinità tossica ma un’inaspettata equità di giudizio (se si esclude che nessun uomo verrebbe apostrofato per un errore enorme con la frase “brutta troia imbecille”), passando al tritacarne del capitalismo chiunque senza distinzioni di genere.

Se il film funziona, oltre che per l’abilità nell’evitare quasi tutti i cliché, è anche per le interpretazioni. Un cast trainato dalla protagonista di Bridgerton e da colui che ha sconfitto Cocainorso (ok, ha fatto anche tante altre cose il povero Ehrenreich, ma in che altro modo potevo citare una pellicola su un orso strafatto di cocaina?) non dava gradi speranze, invece Dynevor e Ehrenreich funzionano bene, hanno una buona alchimia quando si amano e ne hanno una ancora migliore quando si detestano. Ad accompagnare il loro campionario di rivalse e crudeltà gratuite c’è un gruppo di colleghi splendidamente detestabile, dal capoclan Campbell interpretato da Eddie Marsan (uno che ho scoperto con quel gioiellino di delicatezza che risponde al nome di Still life e che invece si dimostra perfetto nel ruolo di cattivo, come dimostrato anche dalla serie Ragazze elettriche) al giovincello rampante interpretato da Sebastian De Souza, il cui sorrisetto beffardo perennemente stampato in volto ti fa venire voglia di entrare nello schermo per prenderlo a schiaffi (ma anche questa è mascolinità tossica). Mentre la trama si dipana verso un finale meno scontato del previsto (che non è quello scritto in questo articolo, pubblicato da qualcun* che ha guardato il film con mezzo occhio SE l’ha guardato) la tensione rimane alta, con la possibilità che la relazione con Luke possa venire allo scoperto a pendere come una spada di Damocle sulla testa già abbastanza piena di pensieri di Emily: in tutto questo Domont può permettersi pure di buttare lì la classica pistola checoviana (sotto forma di assegno) senza sentire la necessità di farla sparare.

Per quanto abbia evidenziato più in alto che il lato erotico di Fair play è tutt’altro che preponderante, quel lato c’è e si sente: Domont cerca e trova il modo di spogliare Dynevor spesso e volentieri (senza però mai far vedere troppo), ma le scene di sesso finiscono per portare avanti la narrazione efficacemente invece di risultare semplici momenti pruriginosi obbligati. In questi momenti la regista riesce a mostrare il desiderio sessuale in maniera non stereotipata, sia dal lato maschile che da quello femminile, ma il sesso in sé è filmato con il solito immaginario da film porno: il corpo di Emily reagisce agli stimoli secondo i dettami del male gaze, pronto all’uso immediatamente in qualsiasi situazione, e per quanto voglia evitare l’errore di definirmi esperto di ciclo mestruale (da maschio bianco va da sé che non me lo posso permettere) l’aver partecipato alla presentazione del libro Questo è il ciclo di Anna Buzzoni mi rende poco credibile una donna che non si accorge dell’arrivo delle mestruazioni, ritrovandosi inconsapevolmente nel pieno di quello che la protagonista di Crazy ex girlfriend chiamerebbe “period sex” (anche se va applaudito il coraggio di inserire questa scena subito all’inizio). Assieme alla censura del pene (cui ho dedicato questo articolo) è un altro dei modi di rappresentare il sesso che andrebbe superato, ma anche al netto di questi difetti Fair play resta non certo un capolavoro, ma un ottimo film che riesce a sviluppare le premesse in maniera credibile e con dei buoni lampi d’inventiva.
Netflix sta migliorando la qualità dei suoi prodotti originali quindi? Vorrei tanto dirvi di sì, ma dopo aver iniziato a scrivere questo articolo ho scoperto che in realtà il film era stato presentato al Sundance a gennaio e solo in un secondo momento la grande N ne ha acquisito i diritti di distribuzione: accontentiamoci del fatto che se non altro i dirigenti questa volta hanno scommesso sul cavallo giusto, e perdonatemi se potete per lo sfogo iniziale che, a conti fatti, risulta totalmente ingiustificato. O no?
Ti è piaciuto questo racconto/articolo? Segui la pagina Facebook di Tremila Battute!
Scarica il numero Zero e il numero Uno della fanzine di Tremila Battute!