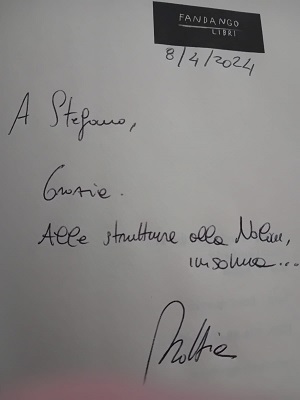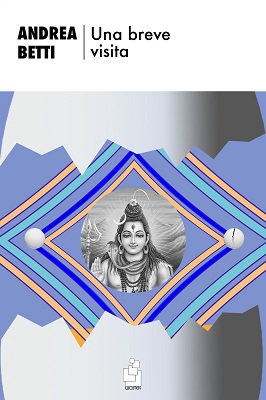Quando ancora avevo una band e potevo definirmi un musicista uno dei miei più grandi sogni era quello di esibirmi in una situazione simile a questa: i Kyuss che suonano nel deserto in mezzo a un sacco di gente. Davvero in mezzo eh! Una roba che puoi fare solo a un certo livello di popolarità, abbastanza alta da attirare gente (mica che ti ritrovi, come gli Skruigners a inizio carriera, con sei persone davanti di cui tre pogano e le altre tre gli saltano in testa dal palco) ma non abbastanza da attirarne un fiume, che poi a livello di sicurezza diventa complicato… Ed è meglio non averla, la sicurezza, se vuoi rendere tutto spontaneo e magnifico come me lo immaginavo io.
Negli anni situazioni del genere le ho vissute, nel mio strapiccolo. Non nel deserto ovviamente, che la pianura padana a tutto assomiglia tranne che al Joshua Tree, e non con in mano uno strumento, ma col palco improvvisato fra il pubblico ho visto i Mood, i bustesi Fuyumeku, ho sperato di vederci anche i rumorosissimi Lightning Bolt al Leoncavallo qualche anno fa perché avevo letto che così facevano i loro concerti e invece no, quella sera erano su un palco normale staccati dalla folla (c’erano notizie peggiori nell’aria, visto che era la stessa sera dell’attentato al Bataclan di Parigi). La prima volta in cui però mi è capitato di trovarmi in una situazione simile è stato al primo, mitico MiOdi, il contraltare distorto del MiAmi che negli anni sarebbe diventato il Solomacello Fest: fra un concerto e l’altro, senza nessuna avvisaglia, un duo chitarra e batteria iniziò a suonare in mezzo allo spiazzo cementificato del Magnolia e ad attrarre gente intorno a sé, coinvolgendo anche solo per quanto era bizzarra e improvvisata la performance. Quel duo erano i Nurse!Nurse!Nurse! (che ancora oggi ritengo un nome fighissimo), e alla batteria c’era Johnny Mox.
Gianluca Taraborelli l’ho conosciuto come batterista, ma negli anni è diventato reverendo e stregone, rimanendo sempre uno sperimentatore. La sua trasformazione nel Reverendo Johnny Mox avviene nel 2012 con l’uscita di We=Trouble (Musica per Organi Caldi, Whosbrain Records), disco dove Taraborelli inizia a sperimentare con loop vocali e suoni che pescano dagli ambiti più disparati, dal noise al rap, creando una versione postmoderna del gospel che ne mantiene inalterata la carica spirituale e sociale (la terza traccia All We ever wanted was Everything è stata registrata a Nairobi, un dettaglio importante per ciò che avverrà più avanti nella sua carriera). Passa solo un anno e il suo nome si avvicina alle mie orecchie con l’Ep Lord Only Knows how many times I cursed these Walls, uscito ancora con l’aiuto di Musica per Organi Caldi più Sons of Vesta, Escape from Today e Solomacello, ne passa un altro e mi si ficca in testa con ancora più insistenza visto che il Reverendo esce con uno split in compagnia dei Gazebo Penguins (cui avevamo dedicato uno dei primi racconti del blog), Santa Massenza. Di stare fermo Mox non ne ha proprio voglia, e il 2015 è l’anno in cui mi arriva in mano Obstinate sermons, prodotto da talmente tante etichette, a guardare il suo Bandcamp, che citiamo per sintesi Woodworm, To Lose La Track (che gli resterà al fianco per il resto della carriera) e la V4V di Mike Montagano (per il cui blog StorDisco scrivevo ai tempi): mi si apre un mondo, mi si stacca la testa dal collo a furia di fare headbang su They told me to have faith and all I got was the sacred dirt of my empty hands, mi si inquieta l’anima di fronte alla spettralità lancinante di The long drape e mi si riempie il cuore di ammirazione quando mi rendo conto che la batteria è fatta con la voce. Il rap citato in partenza infatti non è un orpello messo lì senza saperne, perché Mox della scena ne sa e sa anche fare beatbox, cosa che, come mi è capitato di vedere un paio di volte, nei suoi live insegna al pubblico (provate a dire sempre più velocemente “puzza di cazzo” e vedete l’effetto che fa, ma fatelo sotto la doccia se non volete ritrovarvi la casa piena di sputi).
Passano alcuni anni prima che il Reverendo torni a farsi vivo e me ne accorgo al Lato B di Finale Emilia, durante la quinta Festa del ringraziamento organizzata dal circolo, dove il nostro si esibisce con tanto di band alle spalle, i The Moxsters of the Universe. È appena uscito Future is not coming… But you will, che dal vivo con la band mostra tutto il blues che sta nell’animo del Reverendo, ma in quei tre anni Taraborelli non ha solo progettato quel disco, anzi: in coppia con il chitarrista e manipolatore di suoni Marco Bernacchia, meglio conosciuto col moniker Above The Tree, ha fatto partire il progetto Stregoni. Partire nel vero senso della parola perché il duo in tre anni suona dovunque in Italia e all’estero, e non suona da solo: Stregoni è infatti un progetto a metà fra il live e il workshop, si propone di attirare e far suonare richiedenti asilo di ogni nazionalità e si esibisce ogni volta con una formazione diversa, in un caleidoscopio di influenze e di apertura diametralmente opposta ai diktat sull’immigrazione dell’UE tutta e del governo gialloverde in quello specifico momento storico. Riassumere quell’esperienza è difficile, soprattutto non avendo potuto essere presente, ma vi consiglio di informarvi a partire da questa intervista su Sentire Ascoltare per farvi un’idea di come la musica possa farsi promotrice di un miglioramento nella società.
Sperimentatore sempre, dicevo all’inizio, e Mox lo dimostra ancora nel 2019 con Spiritual Void, album composto da un’unica traccia di sedici minuti registrata fra i boschi del Trentino da cui proviene e che, nomen omen, si manifesta come esperienza spirituale oltre che musicale. Nel 2020 approccia per la prima volta l’italiano nell’Ep di due tracce Hyper Gospel. 1, poi fa il salto quantico e torna sul finire del 2023 con Anni Venti, un disco in italiano nel quale la matrice hip hop che ha sempre fatto parte del suo percorso artistico si fa preponderante, amplificando ancora di più la componente sociale che sta dietro alla sua musica. “Scaricare i costi delle crisi sulla pelle della gente è una forma di violenza che oramai chiamiamo tutti resilienza”, canta Mox in Pensiero collettivo, e fra una frecciatina al Massimo Pericolo di Sette miliardi in Non si torna più indietro e l’esplicitazione sarcastica dello stigma della povertà ne I poveri il reverendo che si è fatto stregone incanta ancora, sempre con la sua fidata cassa su cui salire a fare sermoni davanti al pubblico… e chissà se è la stessa con cui ha suonato quella volta al Magnolia?
Ho esplicitato più volte la mia ignoranza linguistica riguardo all’inglese (non che con l’italiano sia messo meglio, visto come ho formulato la frase che precede questa parentesi), motivo per cui fin dalla fondazione di questo blog ho immaginato dietro alle parole di The long drape una storia che volevo raccontare ma che, non riuscendo a capire il testo, non sapevo raccontare efficacemente. Johnny Mox stesso mi è venuto in soccorso inviandomi il testo della canzone e così questo racconto ha infine trovato vita, facendosi fotografia sbiadita di un matrimonio meno felice di quel che dovrebbe essere: il perché potete scoprirlo andando a leggerlo subito dopo aver ascoltato la canzone che lo ha ispirato, a me non resta che ringraziare Gialuca per il dono e augurare a tutt* voi buon ascolto e buona lettura.
Se volete ascoltare questo e tutti (o quasi) gli altri brani che hanno ispirato i racconti di Tremila battute ora potete farlo tramite questa comodissima playlist su Spotify: in attesa di trovare un canale che ricompensi davvero gli artisti accontentiamoci di quel che passa il convento e ascoltate, condividete, supportate (e se avete canali alternativi suggeriteli nei commenti).
Scarica il numero Zero e il numero Uno della fanzine di Tremila Battute!
Bellezza
Tutti i soldi del mondo non faranno mai tornare il vestito come prima. Lui era convinto di poterle donare tutto, il mondo intero in cambio della sua bellezza, e invece guarda.
Era davvero radiosa, mentre camminava verso l’altare. Lui non aveva mai pensato che potesse esserlo così tanto, anche se l’aveva sposata contro il parere di tutti, anche se aveva visto qualcosa nella sguattera che altri avrebbero preso solo come amante, lasciandole al massimo un figlio bastardo e qualche minaccia a intimarle il silenzio prima di essere cacciata. Lui no, lui aveva capito a cosa serviva davvero la ricchezza.
Ma la ricchezza non può rimediare a tutto quel sangue. Nemmeno la miglior sarta del mondo saprà ricucire abbastanza bene da nascondere la violenza. Non se l’aspettava così la prima notte di nozze, quando ancora piccola ne parlava con la madre, giocando con un asciugamano a farle da velo mentre dalla stanza accanto suo fratello tossiva l’anima e i sorrisi si spegnevano all’istante. Lui non sarebbe riuscito ad accompagnarla all’altare, nessuno dei suoi fratelli ci sarebbe riuscito.
A quel tempo suo padre se n’era andato già da un bel pezzo, litaniando bestemmie che l’avrebbero portato molto più in basso della miniera in cui aveva lasciato i polmoni.
Con tutti i soldi del mondo, pensa, bisognerebbe inventare un sapone che sappia pulire ogni cosa. I vestiti, i pensieri, le anime. Pulire i giorni, smacchiarli dal rancore, renderli lindi e scintillanti come appaiono in superficie. E invece.
Verso l’altare della chiesa si può imparare a camminare con grazia in ogni situazione. Col vestito bianco, con quello nero. Quando seppellisci tutti i tuoi fratelli, tutte le tue sorelle, tuo padre, tua madre per ultima, col cuore spezzato dai troppi lutti, impari a fingere che sia tutto normale. Impari a fingere che si possa amare la morte, perché la morte ha un nome e un indirizzo.
Puoi decidere che il giorno più bello della tua vita non ha a che fare con l’amore, ma con la vendetta.
Continua a strofinare, ma le macchie di sangue resistono. Non che serva a granché nascondere, ma sarebbe così bello, qualcosa di davvero bello, poterne uscire pulita. Guarda il velo candido gettato in un angolo, l’unica parte del vestito ancora intonsa, l’unica parte a cui lui non si è aggrappato per evitare di andare a fare compagnia a suo padre, una coltellata alla volta: una morte fin troppo veloce.
Prende in mano il velo, saggia la consistenza della stoffa, pensa ai soldi che è costato, alle vite buttate per poterlo acquistare. Lo posa sul proprio capo: quando verranno a prenderla sarà la sua corona, regina per una sola notte.
Ti è piaciuto questo racconto/articolo? Segui la pagina Facebook di Tremila Battute!