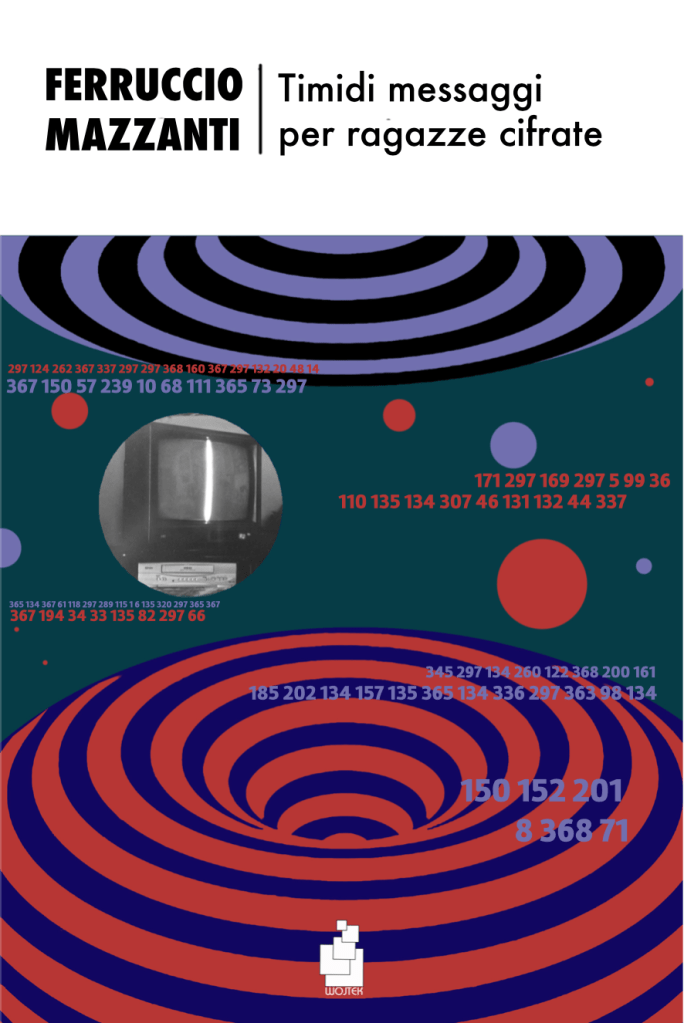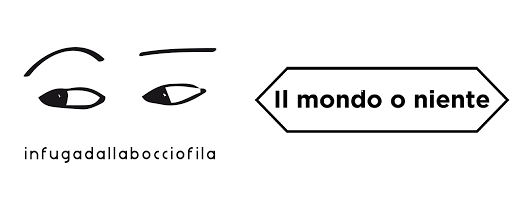Quando sono partito col progetto di questo blog, poco più di un anno fa (tanti auguri!), l’ho fatto con l’obiettivo di dare risalto a musica che apprezzavo e che faticava ad arrivare alle masse: allo stesso tempo volevo scoprirne di nuova, giusto per non finire a parlare solo di ciò che già conoscevo. Ammetto che in questo, con una logica del “ma ha fatto anche cose buone” che non mi appartiene, devo ringraziare pure quello Spotify che condanno apertamente linkando ogni volta un articolo sulle briciole che lascia agli artisti (lo trovate più in basso, prima del brano della settimana). Il modo in cui mi ha aiutato l’app su cui si mettono a litigare gli artisti che condannano la vecchia industria discografica è stata la Discover weekly, la playlist dedicata che amplifica il mio terrore riguardo agli algoritmi (“se dico a Spotify che questo brano non mi piace poi smetterà di farmi sentire QUALUNQUE canzone di questo genere?”) e allo stesso tempo porta alle mie orecchie suoni nuovi o, quantomeno, band che non conosco, visto che comunque si basa all’incirca su quelli che pensa essere i miei gusti: tutto questo giro di parole per dire che i Vessels, resident band della settimana, li ho scoperti in questa maniera, grazie a un brano stipato in fondo ad una playlist automatica in cui figurava, chissà perché, un sacco di post-punk che evidentemente l’algoritmo ha deciso piacermi al di sopra di ogni cosa (non è così).
Non fingerò di conoscere vita, morte e miracoli dei Vessels, dato che ammesso poche righe sopra di non sapere niente di loro fino a poco tempo fa. Posso però dire cosa mi ha attratto inizialmente della band di Leeds, e cosa mi ha colpito approfondendone la conoscenza. Parecchi mesi fa ho tributato un racconto ai Fuck Buttons, duo elettronico di Bristol, e nell’articolo di corredo mi auguravo prima o poi di trovare qualcosa che suonasse in maniera simile a quel groviglio di suoni sintetici orchestrati con animo da band post-rock: i Vessels è su questo stesso campo che si spingono (non riesco a non pensare che manchi l’influenza del duo in questo brano), con la differenza sostanziale che loro dal post-rock, perlopiù strumenti alla mano e (poca) voce, ci sono partiti, per poi lasciarsi andare sempre più a una sperimentazione elettronica forse più ossessiva e meno orchestrale dei Fuck Buttons, ma comunque capace di far viaggiare la mente. Pregio ulteriore di questa continua evoluzione, partita dall’esordio omonimo del 2006 per arrivare, attraverso altri tre album e un Ep, a The great distraction del 2017, è il fatto che i Vessels non sono mai mutati come formazione (Tom Evans inserti elettronici e voce, Tom Mitchell batteria, Martin Teff chitarra, basso e synth, Lee J. Malcolm inserti elettronici, synth e batteria, Peter Wright inserti elettronici) passando agevolmente da un brano come questo a uno come questo spinti solo dalla curiosità verso le mille direzioni non scontate che può prendere la passione per la musica: non so a voi, ma a me questo basta per farmeli amare.
Glass lake, canzone a cui è ispirato il racconto della settimana, arriva dal terzo album Dilate, quello che ha segnato la svolta decisa verso l’elettronica (sul loro Bandcamp parlano di focus sulla “euphoria of the dancefloor”). Un brano apparentemente freddo ma allo stesso tempo pervaso da un’atmosfera distesa e sognante, in cui la batteria ha un qualcosa di tribale, che partendo dal titolo mi ha ispirato una storia di riti ancestrali e, come da titolo del racconto, passaggi di consegne fra il mistico e l’inquietante: trovate il racconto dopo il brano, a me non resta che augurarvi come al solito buon ascolto e buona lettura.
Se volete ascoltare questo e tutti gli altri brani che hanno ispirato i racconti di Tremila battute ora potete farlo tramite questa comodissima playlist su Spotify: in attesa di trovare un canale che ricompensi davvero gli artisti accontentiamoci di quel che passa il convento e ascoltate, condividete, supportate (e se avete canali alternativi suggeriteli nei commenti, questo è l’unico dove sono riuscito a trovare tutte le canzoni).
Passaggio di consegne
Quando arrivò il momento ci dirigemmo verso il lago, come i nostri padri avevano fatto prima di noi. Lasciammo tutto così com’era, senza annunciare a nessuno il nostro viaggio: seguire la propria natura non necessita spiegazioni.
Arrivammo al tramonto, col cielo di un vivido rosso che si specchiava nell’acqua calma. Gli alberi ci invitarono a unirci a loro, creando un sentiero al nostro passaggio fino alla radura sacra. Uno di noi attizzò il fuoco, con sterpi e rami che la natura ci offriva in dono; un altro dispose i tamburi, in modo che potessimo guardarci attraverso le fiamme mentre suonavamo; un altro salmodiò i canti durante tutta la preparazione, affinché ogni cosa andasse com’era sempre andata: affinché il nostro futuro si legasse al nostro passato.
Aspettammo la notte, il canto dei gufi e il lamento dei lupi, prima di iniziare a battere sulle pelli il ritmo che ci cresceva nel sangue. Le vette degli alberi ci osservavano immote, il vento morì nel cerchio che ci ospitava, le ombre iniziarono a danzare sui nostri volti e a loro ci unimmo, a turno, stringendo mani di tenebra. Seguimmo passi già segnati da altri prima di noi, facendoli nostri come ultimo omaggio agli antenati, ad occhi chiusi ballammo e suonammo finché dalle acque vicine non iniziammo a sentire un suono rispondere alle nostre invocazioni, ai nostri battiti, sempre più forte, sempre più veloce.
Chiudemmo gli occhi, roteando ancora, ballando attorno a un fuoco che non ci scaldava più. Udimmo a malapena lo sfrigolio con cui l’acqua spegneva la fiamma, mentre nelle nostre teste un urlo ancestrale ci spingeva a muoverci in tondo ancora e ancora, sempre più lenti man mano che le energie ci venivano risucchiate dalle ombre della notte, sempre più freddi a ogni giravolta. All’apice dello sforzo e dell’agonia urlammo, come creature spaventate che venivano al mondo: ma l’energia di quell’urlo ci fu sottratta dalla gola.
Ci svegliò dolcemente il sole, scaldandoci coi suoi raggi. Nella radura regnava la pace, le foglie degli alberi si agitavano dolcemente, invitandoci al movimento. Camminammo lungo un sentiero di luce, nelle orecchie lo sciabordio delle acque e un invito, perentorio e soave al tempo stesso: erano i nostri spiriti, gli spiriti che i nostri padri ci avevano donato, a chiamarci dal fondo del lago.
L’acqua immobile ci attendeva, riverberando nel giorno già nato; ci specchiammo sulla sua superficie, vedendoci giovani e sgravati dal peso degli anni; ci accarezzò il riflesso, cingendoci poi in un tenero abbraccio; restammo così a lungo, a guardarci rivivere nei nostri figli, fino a che le profondità non ci reclamarono come avevano reclamato i nostri padri.
Ti è piaciuto questo racconto/articolo? Segui la pagina Facebook di Tremila Battute!