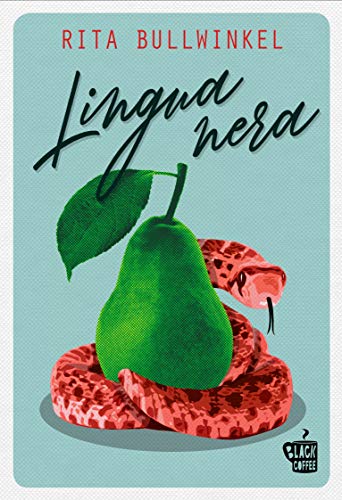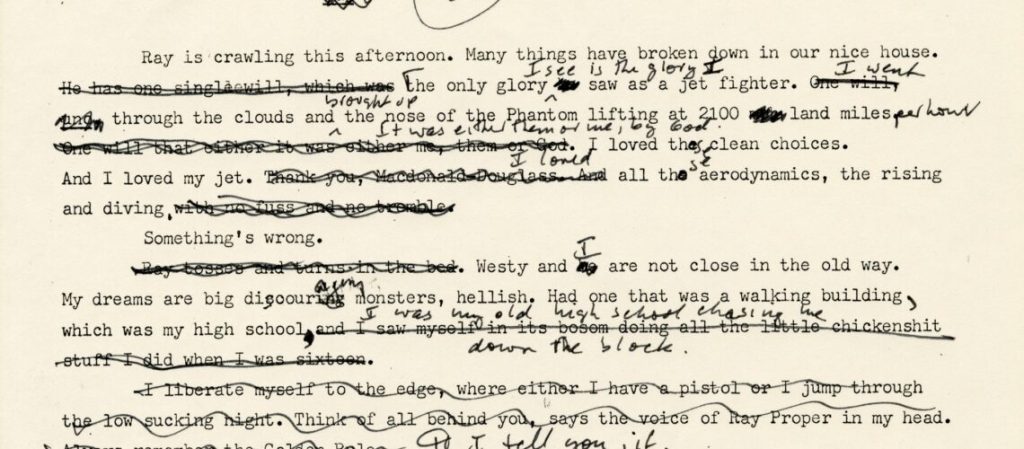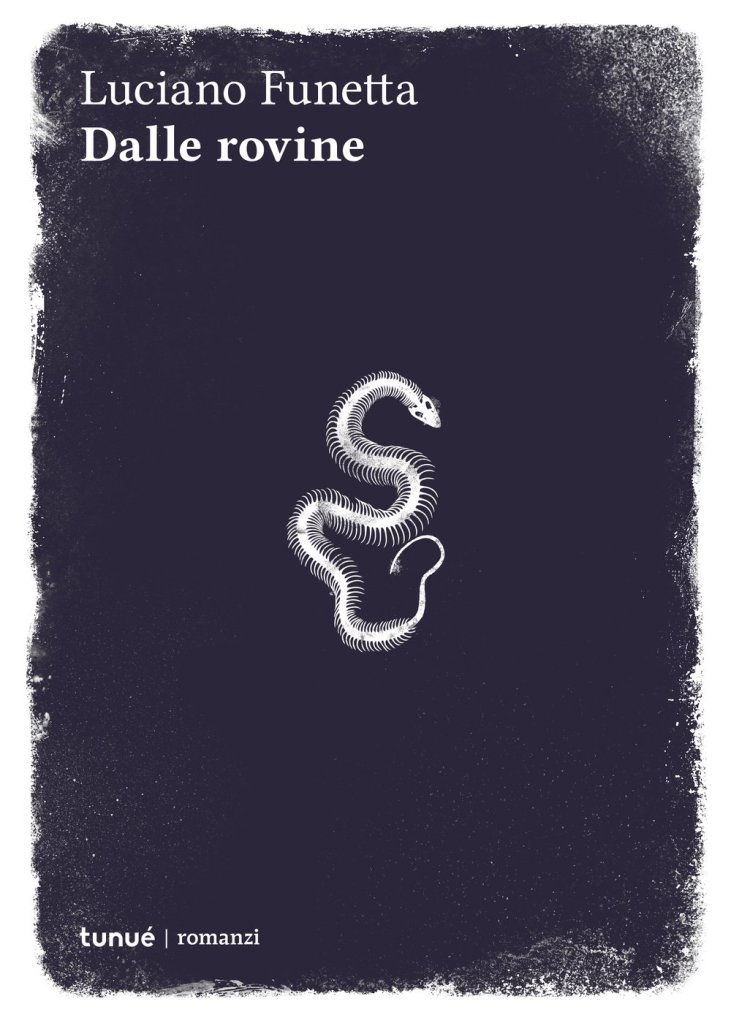Pensate a tutta la musica che avete scoperto grazie ai consigli di amici. A volte basta anche solo un po’ di tempo per approfondire e un link su un social network postato da qualcuno di cui vi fidate o, se proprio siete avventurosi, da qualcuno i cui gusti non corrispondono ai vostri. In questo blog cerco di essere quell’amico che pubblica link, e molto probabilmente sono più spesso quello dai gusti strambi, ma anche a me piace fare nuove scoperte. Le collaborazioni, oltre che a riempirmi il cuore con la passione di altri scrittori, servono anche a rendere Tremila Battute uno spazio di scoperta musicale per me stesso, e una bacheca musicale che rifletta gusti che non siano per forza sempre i miei. Ringrazio quindi questa settimana Davide Ceraso, per avermi donato un bellissimo racconto e dato modo di conoscere una nuova band, i Kaufman.
Davide nasce a Cuneo nel 1976, ha una moglie, due figlie di nome Cloe e Camilla e un cane, che lo segue ovunque vada. Scrive seduto sulle carrozze dei treni che lo portano a lavoro o nelle notti insonni, e scrive davvero bene: ve lo avevo segnalato già in un vecchio articolo, in cui suggerivo la lettura del suo Pelé pubblicato su Rivista Blam. Di racconti Davide ne ha pubblicati molti, uno nel libro Quartieri edito da La Feluca Edizioni, altri su svariate riviste letterarie: Crack, Marvin, Voce del verbo, Smezziamo, Spore, Malgrado le mosche, Neutopia, Bomarscé, La seppia, Mirino e prossimamente su Formicaleone. Collabora con il sito H.A.N.D. – Have A Nice Day e ha pubblicato il romanzo La direzione della coccinella per DZ Edizioni a luglio 2020: dove trovi il tempo per fare tutte queste cose non lo so, ma spero che mi riveli il suo segreto quanto prima.
Dopo due album in inglese (Modern sprawl nel 2007 e Interstellar college radio nel 2009) i Kaufman, band bresciana capitanata da Lorenzo Lombardi , incidono nel 2011 il primo album in italiano, Magnolia. È questo il momento in cui cominciano a ibridare le suggestioni indie col pop, e ad attirare l’attenzione di nomi importanti come Omar Pedrini, ospite nel singolo Improvvisamente tu. Passati all’etichetta Irma Records, nel 2014 i Kaufman pubblicano l’album Le tempeste che abbiamo, nel quale inizia un sodalizio con il cantautore Alessandro Raina che produrrà anche il loro album seguente, Belmondo, edito dalla casa discografica torinese Inri nel 2017 (curiosità: scopro solo ora che Raina nel 2013 conduceva su Radio Popolare un programma radiofonico in cui scriveva racconti basati su canzoni). Stabilizzatisi col tempo in una formazione che comprende Alessandro Micheli, Matteo Cozza e Simone Gelmini, i Kaufman (il cui nome omaggia il seminale comico statunitense Andy Kaufman) hanno fatto uscire da pochi mesi la canzone Lelaina, ultimo di una serie di singoli scaglionati fra il 2019 e il 2020 in attesa di uscire con un nuovo disco.
Magnolia, terzo singolo estratto dall’album omonimo, è una canzone delicata che, nelle parole di Lombardi, rappresenta un collage di immagini su una storia che potrebbe o non potrebbe finire, con New York sullo sfondo e la neve che si confonde coi fiori di magnolia. Davide Ceraso, forse influenzato anche dal video che potete vedere qui sotto, ne ha tratto un racconto in cui dolore e speranza hanno lo stesso spazio: per capire quale delle due vincerà non avete che da andare a leggere il racconto, a me non resta che augurarvi buon ascolto e buona lettura.
Se volete ascoltare questo e tutti gli altri brani che hanno ispirato i racconti di Tremila battute ora potete farlo tramite questa comodissima playlist su Spotify: in attesa di trovare un canale che ricompensi davvero gli artisti accontentiamoci di quel che passa il convento e ascoltate, condividete, supportate (e se avete canali alternativi suggeriteli nei commenti, questo è l’unico dove sono riuscito a trovare tutte le canzoni).
Magnolia, di Davide Ceraso
L’inverno prova a sopravvivere ancora qualche ora, scende all’alba da un cielo vestito di nuvole madreperla, in silenzio, annodato a una nevicata esangue, troppo fragile per battagliare con l’aria di primavera e per non dissolversi nelle crepe dell’asfalto.
Carlotta è in piedi, le braccia lungo i fianchi, immobile al centro del dehors che custodisce il suo corpo di bambina come una teca di cristallo protegge un tesoro. Osserva attraverso pareti trasparenti i fiocchi di neve annegare nella strada deserta mentre alla sua sinistra, impilati uno sull’altro, alla rinfusa, tavolini e sedie incastrano le rigide membra per non scivolare su assi di compensato impregnate dell’odore acre di nicotina. D’improvviso Carlotta si volta, gli occhi dalle sfumature smeraldo come quelli di sua madre fissano il mio viso stanco. Allora incurvo le labbra verso il soffitto buio del bar, appena appena, per un attimo accenno un sorriso, falso quasi quanto la voglia di ricominciare tutto daccapo, dall’inizio, ancora una volta. Lei però non ci fa caso, o quantomeno non traspare dallo sguardo, saluta con un cenno della mano prima di allargare le braccia, ali senza piume, e iniziare a ballare su di una musica che soltanto le sue orecchie sono in grado di percepire.
Socchiudo gli occhi e ripenso a ieri sera, all’ultimo giorno in quella casa, noi due, soli, stretti in un abbraccio, le parole sussurrate di un padre chiedono perdono alla figlia per ogni ferita che le ha regalato e che non avrà più indietro, singhiozzi sincopati che la notte ha poi coagulato in respiri leggeri e cuori che battono all’unisono.
«Papà…»
Sobbalzo, la voce di Carlotta dirada i miei pensieri.
«…andiamo a trovare mamma?»
Annuisco, chiudo la serranda che urla stridula nelle guide maculate di ruggine e come ogni domenica raggiungiamo il Monumentale, a piedi, senza fretta, Torino a spiare di spalle i nostri discorsi distratti, finché isoliamo i pensieri da ciò che li circonda difronte alla lapide di Martina. La sua immagine, impressa in una fotografia stondata, osserva un punto lontano, indefinito, pare ignorarci, come se fossimo esseri invisibili, contorni sbiaditi di ombre sconosciute. Carlotta si avvicina e anneghiamo nei ricordi, intrecciamo insieme le nostre dita, sento il calore della sua pelle e riaffiora dal nulla la voglia di continuare a lottare, una febbre lucida, il desiderio di risalire verso la superficie del mare vuoto che ha inghiottito l’anima, per mia figlia, un fiore sbocciato su di un ramo così nudo da sembrare morto ma al cui interno, nel profondo, scorre linfa al profumo di vita. Asciughiamo le lacrime e quando usciamo in strada, rallento il passo, Carlotta mi guarda, un paio di metri avanti, perplessa, la sciarpa al collo, i capelli mossi dal vento. Io sorrido, di nuovo, sorrido al mio fiore, al mio piccolo fiore di magnolia…
Ti è piaciuto questo racconto/articolo? Segui la pagina Facebook di Tremila Battute!