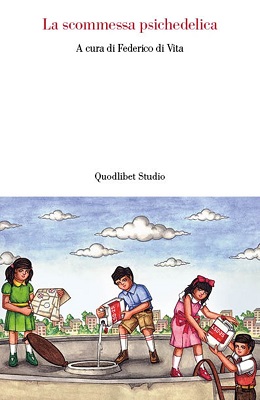Voi ci pensate mai alla vita dell* Influencer? Io sì. A volte penso a come fanno a tirar fuori qualcosa da dire ogni giorno, tipo che mi metto nei panni dei Me Contro Te e immagino che anche oggi dovrò fare un video con montaggio epilettico parlando di niente con una vocina odiosa; più spesso, però, mi chiedo come si fa a stare dietro a community di follower sterminate, e ok che una volta che hai fatto i soldi puoi anche permetterti di avere qualcuno che risponde per te ma non è un tradimento? Segui me o il mio ufficio stampa? Come potrei io, in quei panni, guardarmi ancora allo specchio sapendo di tradire la pletora di gente che mi segue? First world problem, come potete intuire (aggiungiamoci che quanto scritto sopra non segue la regola del tre, avendo fatto solo due esempi di “a cosa penso quando penso agli Influencer”, e questo scombussola il mio relativo bisogno d’ordine).
Per fortuna a me e a questo blog ci s’incula quasi nessuno, altrimenti sai lo stress? Io già mi sento in colpa quando non rispondo per due giorni alle mail di chi mi contatta, quando faccio passare sotto silenzio un comunicato stampa dando per inteso che “ci sentiamo se ne parlo” e quando finisco per non parlare di dischi interessanti perché ho voglia di parlare anche di, che so, peni su grande e piccolo schermo (prima o poi lo farò, anche se nel frattempo mi hanno già anticipato), figurati se mi arrivassero migliaia di dischi! Al racconto di questa settimana ci pensavo già da tempo (ho usato il verbo pensare un po’ in tutte le salse fino a questo punto eh?), per dare il giusto spazio a una band di cui non ho parlato all’uscita del loro bel disco, poi sta settimana mi è partita l’ispirazione e così anche i Northway entrano finalmente nella grande famiglia di Tremila Battute.
I Northway sono solo l’ultima band che mi capita di scoprire nel panorama post-rock bergamasco, terreno fertile di suoni buoni che ha già dato alla luce negli anni band come Verbal, Teich e, andando poco più in là, quei matti dei Bangarang!. Nati nel 2014 attorno a un nucleo composto da Antonio Tolomeo (chitarra), Andrea Rodari (batteria) e Matteo Locatelli (basso), già militanti precedentemente in una band alternative rock, con l’ingresso della seconda chitarra di Giuseppe Procida i Northway iniziano a sperimentare coi suoni e decidono che per far questo non hanno bisogno della voce: se vi state chiedendo “ma stai per caso parlando di un altro gruppo strumentale?” sappiate che sì, è proprio così. Il primo album, Small things, true love, vede la luce nel 2017 ed è un affresco in cinque brani di ciò che il post-rock dovrebbe essere: evocativo, a volte brutale, musica che ti porta altrove e libera la tua mente. Registrato in quel gran posto che è il Trai Studio di Fabio Intraina (ci hanno registrato anche amici miei, e ne sono venuti fuori sempre con dischi della madonna), il primo album dei Northway inserisce nei titoli suggestioni cinematografiche (Arrival, The Martian, anche se quest’ultima si apre con registrazioni di uno sbarco sulla Luna) e letterarie (Jules Verne, e vogliamo forse non pensare che quel The King che dà il titolo alla seconda traccia non sia Stephen King? Con quel basso possente e vagamente inquietante in apertura?), mostrando ottime qualità ancorate però ancora a stilemi poco personali.
Successivamente alla pubblicazione Procida esce dal gruppo a causa del trasferimento in Puglia, sostituito da Luca Labo: con questa formazione la band ricomincia a calcare palchi e creare nuovi brani, arrivando al 2019 con abbastanza materiale per chiudersi nuovamente in studio di registrazione. Per The Hovering non cambia il luogo prescelto (sempre il Trai), ma cambia il supporto produttivo, visto che il disco esce per la benemerita etichetta I Dischi del Minollo i cui gruppi hanno spesso trovato spazio su queste schermate: i sei brani ruotano attorno a un concept marittimo e allargano gli orizzonti sonori della band, mantenendo inalterato quell’equilibrio fra momenti riflessivi e sfoghi elettrici che fanno dei Northway forse non la più originale band del panorama, ma sicuramente una delle più abili a coinvolgerti nel loro mondo sonoro. The Hovering esce nel settembre 2020 e, va da sé, la situazione concerti era quella che era: speriamo che il 2022 li porti a suonare più spesso per dare a quei brani il respiro della dimensione live, dove li si potrà vedere in una formazione che, al posto di Labo, ora vede alla seconda chitarra Luca Laboccetta.
Ho ragionato spesso, nei mesi trascorsi da quando ho ricevuto il disco, su come trasporre in forma di racconto le suggestioni che mi arrivavano dalla seconda traccia di The Hovering, Kraken. Alla fine però è stato Hope in the storm, il brano seguente, a donarmi l’ispirazione per il racconto di questa settimana, facendo germogliare un’immagine che già mi girava in testa da tempo: quella di una donna anziana che, mentre un’evento climatico devastante si avvicina (una tempesta? Un uragano? Poco importa), decide di restare dov’è e non fuggire. Come va a finire (forse) questa breve storia lo potete scoprire più in basso, subito dopo il brano che ne ha dettato lo svolgimento: a me non resta che augurarvi buon ascolto e buona lettura.
Se volete ascoltare questo e tutti (o quasi) gli altri brani che hanno ispirato i racconti di Tremila battute ora potete farlo tramite questa comodissima playlist su Spotify: in attesa di trovare un canale che ricompensi davvero gli artisti accontentiamoci di quel che passa il convento e ascoltate, condividete, supportate (e se avete canali alternativi suggeriteli nei commenti).
Resistere
Il cielo è ancora sereno ma dicono che pioverà. Non dicono esattamente così, parlano di disastri ed evacuazioni, ma lei ne ha viste tante nella vita e non sarà un po’ di pioggia a smuoverla da qui.
Gli anni creano legami di parentela. Passa il tempo, e le tue ossa scoprono insospettabili affinità coi materiali di cui sono composte le pareti. Più invecchi, più la gente tende a identificarti col posto in cui abiti.
Qualcuno passa con un furgone e rallenta davanti alla sua veranda. Una donna grida dal finestrino e chiede se ha qualcosa da donarle. È come chiederle se ha intenzione di morire, restando qui con tutta quella roba di cui poi non se ne farà niente. Lei si alza e la manda affanculo, poi rientra in casa portandosi dietro la sedia. Il furgone riparte, lento e pesante, fermandosi poche case più in là.
Partire o restare. La mettono giù come se fosse una questione etica, come se abbandonare la propria vita possa essere un concetto assimilabile al bene. L’appartenenza è un equilibrio fra limiti e identità, e lei ha sempre preferito la seconda ai primi.
Quando arriva il disastro, le foto delle vacanze e dei figli bruciano anche da sole. Ammirare il fuoco mentre arde, però, è una decisione personale e non spetta a nessuno giudicarla.
Le assi alle finestre le ha messe. L’ha aiutata un vicino di casa, l’unico che non le ha parlato di futuro e rinascita. Avranno spiccicato un centinaio di parole negli anni, ma sono bastate a intendersi. Mentre si alza il vento guarda la casa buia accanto alla sua, impacchettata come un regalo che si spera di scartare al ritorno: se ci sarà ancora, lei arriverà con la torta e le candeline per festeggiare.
Il rumore dei tuoni fa tremare la terra, ma la terra c’è. Andarsene significherebbe sentirsela levare da sotto i piedi, perdendo in un solo colpo la dignità e l’autonomia. C’è da qualche parte un pasto pronto per lei, un letto in cui riposarsi, un bagno caldo per riscaldarsi le ossa: quello che non c’è è la possibilità di rifiutarsi di sottostare a certe condizioni, la libertà di sentirsi ancora in cammino e non alla fine della corsa.
Che senso ha morire di noia e tristezza? Meglio la musica delle assi che ballano, del vento che ulula la sua gioia. Meglio sentire il battito del cuore che si agita al ritmo delle gocce per un’alternativa vera.
Partire o restare, o anche resistere.
La pioggia scema il suo battere, il vento soffia calmo e invita a uscire. Lei si alza senza fretta, come ha fatto tutto nella vita. Non rimpiange chi se l’è lasciata alle spalle, né chi ha cercato di starle dietro per un po’: la pace all’esterno è simile a quella che prova dentro di sé.
Il sole la illumina. Guarda in alto proteggendosi con una mano, le nuvole la circondano vorticando minacciose. È uno spettacolo incredibile. Sorride: quando gli altri torneranno, pensando di non trovarla più, lei sarà lì a raccontargli che cosa si sono persi.
C’è ancora speranza.
Ti è piaciuto questo racconto/articolo? Segui la pagina Facebook di Tremila Battute!