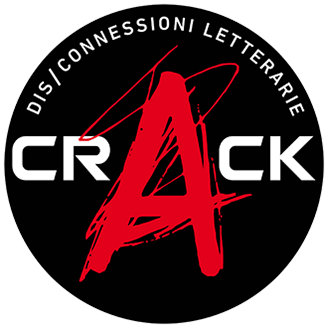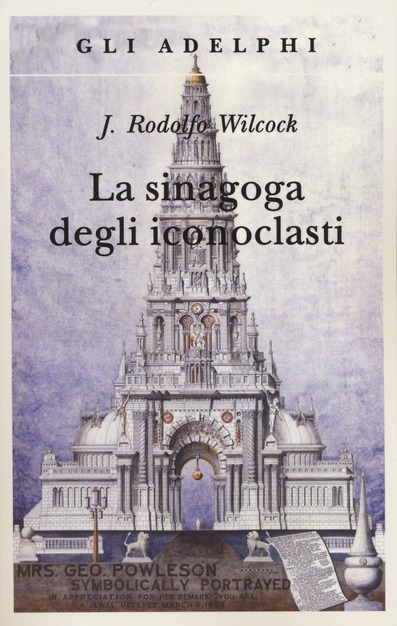A volte non so dire bene come sono arrivato a conoscere un gruppo che mi piace. Può essere che me l’abbia consigliato qualcuno, che abbia suonato in un locale che conosco senza però che sia riuscito a vederli, che abbia incrociato sui social o chissà dove una canzone e abbia deciso di approfondire. Non so quindi dire come sia venuto esattamente a conoscenza della musica degli ZiDima (azzardo totalmente a fallace memoria, come motore della conoscenza, una data alla Cooperativa Portalupi di Vigevano con i compianti Iceberg), di certo ho questo ricordo stampato in testa: io che solitario (nella not…ah no, questo è l’uomo tigre) me ne vado a quella bella iniziativa che era il Generator Party dalle parti di Ivrea (dove mi sarei goduto fra gli altri Muschio, Ruggine e Ash of Nubia), ascoltando a tutto volume il loro disco Buona sopravvivenza e soprattutto canticchiando a ripetizione questa canzone.
Gli ZiDima. il cui nome deriva da un verso di Pirandello (Zi’Dima, dentro la giara, era come un gatto inferocito) sono una di quelle band che, attraverso vari cambi di formazione, vive e lotta con noi (sì, mi piace un sacco usare questa formula) fin dagli anni 90. Il primo parto creativo ufficiale, dopo alcune demo autoprodotte e partecipazioni a compilation, è l’ep L’attesa del 2004, seguito due anni dopo da una compilation creata col collettivo Cadaveri a passeggio, che hanno contribuito a creare, che li porta a suonare per oltre quaranta date in giro per l’Italia. Questa mole di concerti viene condensata nel disco live Nostro lacerante amore del 2008, che anticipa di solo un anno Cobardes, uscito nel novembre 2009 in occasione dell’apertura del processo d’appello per le violenze nella scuola Diaz di Genova…sì, quando parlavo di lotta intendevo anche questo. Nel 2013 registrano il singolo Come farvi lentamente a pezzi, il cui video accompagna la mostra Muri Stracciati di Stefano Belloni, e che entrerà a far parte di Buona sopravvivenza, disco del 2015 grazie al quale ottengono ottimi riscontri dalla critica musicale e che portano in giro per un lungo tour. Qualche anno di silenzio e poi, nel periodo più necessario per dimostrare l’importanza della musica, ecco arrivare a ottobre di quest’anno Del nostro abbraccio ostinato in questa crepa in fondo al mare: sette canzoni che prendono il nome di altrettante persone (più una), un video realizzato nel centro sociale F.O.A. Boccaccio di Monza e un release party proprio in questo luogo, che da anni cerca di fare cultura lottando con continue minacce di sgombero. Gli ZiDima sono oggi Roberto Magnaghi (chitarra), Manuel Cristiano Rastaldi (voce e testi), Cosimo Porcino (basso) e Francesco Borrelli (batteria), e se vorrete intercettarli dal vivo il 31 ottobre li troverete a Saronno, al TelOS (Territorio Libero Occupato Saronnese).
Mi accorgo che ho parlato poco della loro musica qui sopra, un mix di noise rock e post-hardcore su cui si innestano alla perfezione la voce e le liriche di Manuel, musica che potete scaricare gratuitamente dal loro bandcamp (avvertenza solita: gratis non vuol dire che non potete comunque sovvenzionare la band in qualche modo). Tantissima energia, tantissima emozione, quelle che mi hanno portato a immaginare per la loro Chiara, seconda traccia del nuovo disco (col contributo vocale di Alessandro Andriolo dei Selva), una storia che svia dal significato originale cercando di mantenerne intatta la tematica portante: la voglia di riprendersi la libertà. Trovate come al solito il racconto sotto al link della canzone, a me non resta che augurarvi buon ascolto e buona lettura.
Se volete ascoltare questo e tutti gli altri brani che hanno ispirato i racconti di Tremila battute ora potete farlo tramite questa comodissima playlist su Spotify: in attesa di trovare un canale che ricompensi davvero gli artisti accontentiamoci di quel che passa il convento e ascoltate, condividete, supportate (e se avete canali alternativi suggeriteli nei commenti, questo è l’unico dove sono riuscito a trovare tutte le canzoni).
Il coraggio di guardarsi in faccia
Lo capisci che non possiamo più andare avanti così, mi dice con gli occhi lucidi e le mani che tremano, e per quel poco d’amore che mi è rimasto resto ad ascoltarlo mentre mi spiega che un suo amico, uno nuovo suppongo perché gli altri se ne sono andati tutti, potrebbe davvero aiutarci se solo io fossi un po’ gentile con lui, magari stasera stessa. Non pensavo che saremmo arrivati a questo punto, ma ci sono state così tante tappe nella discesa verso il fondo che ormai non riesco più a stupirmi. Almeno non ha il coraggio di guardarmi negli occhi mentre mi chiede cosa ne penso.
Penso, gli dico cercando le parole migliori che ho, che non mi sta bene, che l’unica cosa che non può costringermi a vendere è la mia dignità. Rovino sul finale questo bel discorso, dicendogli che se ne andasse lui, col suo amico, a farselo piantare nel culo. Quando si alza so già quel che mi aspetta, però una soddisfazione sono riuscita a togliermela.
Ma al primo schiaffo me ne accorgo subito che stavolta è diverso, che dopo i lividi e le costole incrinate ci può essere ancora qualcosa di peggio e ho paura, stavolta ne ho davvero tanta e cerco di strisciare via mentre mi tempestano i calci e sì, guardando verso la cucina penso a quanto vorrei avere un coltello in mano, la sua fredda lama a proteggermi dall’uomo che una volta mi amava e ora non si rende nemmeno conto che sta per uccidermi.
La suoneria del suo cellulare mi salva. Lo sento armeggiare frenetico sul tavolo ingombro, rispondere ancora ansimante con quella vocetta stridula che mi aveva fatto tanta tenerezza anni fa, quando non avevamo molto di più ma ci sentivamo fieri di quel poco. Quella fragilità mi aveva convinta a dirgli sì quando mi aveva chiesto di uscire insieme, prima di scoprire di essere la valvola di sfogo ideale per i suoi fallimenti, per il suo non sapersi imporre. Parla al cellulare di un ritardo inaspettato, di un problema risolvibile, e so che quel problema è il mio orgoglio. Quando riattacca sono lontana, non abbastanza per scappare ma spero quel tanto che basta per sfuggire alla sua furia. I suoi passi pesanti, in avvicinamento, mi fanno temere non sia ancora finita.
Non so quali siano le sue intenzioni quando mi afferra per i capelli, dopo che mi sono arrampicata a fatica sul bordo del lavello. Lo dico alla polizia, che non sono riuscita a leggerglielo negli occhi, anche se ho avuto il coraggio di guardarlo in faccia mentre affondavo la lama.
Ora il mio nome è ovunque, tutti vogliono sapere se sono pentita, ma di cosa dovrei chiedere scusa? Di averlo fatto io prima che lo facesse lui? Dicono che eravamo nella stessa situazione, ma non è vero: eravamo entrambi disperati, ma la mia disperazione era doppia. Abbiate almeno il pudore di non giudicarmi, dopo avermi ignorata, perché non dovrete convivere voi col senso di colpa per aver preteso, troppo tardi, la libertà.
Conoscete il mio nome, lo pronunciate con leggerezza, ma non sapete cosa voglia dire essere me.
Ti è piaciuto questo racconto/articolo? Segui la pagina Facebook di Tremila Battute!