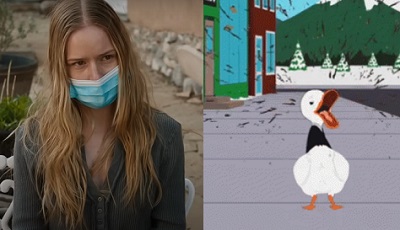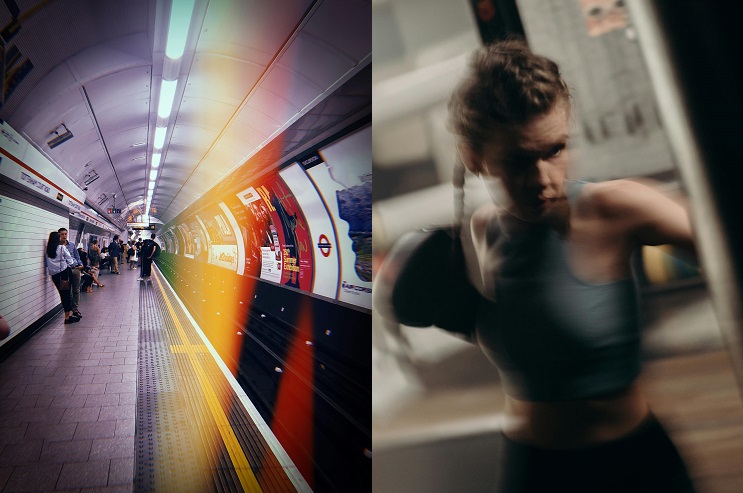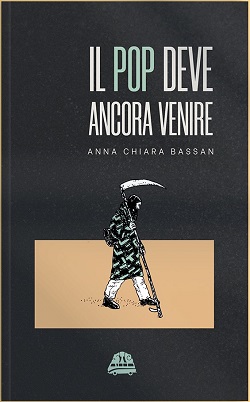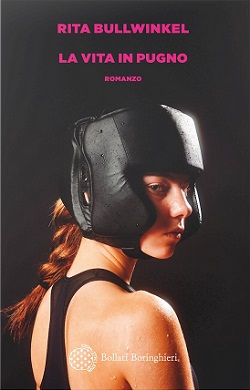C’è un luogo dove non esistono regole, ma solo eccezioni, però sta nella canzone di un artista che difficilmente vedremo mai da queste parti (e penso che a entrambi stia bene così): qui le regole invece ci sono, ma l’inchiostro di quelle non scritte è sempre più simpatico e fra queste c’era la regola “niente doppioni”. Paganini non ripete, si dice, ma qua nessuno si chiama così e alla fine ci siamo ripetuti più volte, iniziando da Edda per poi farci prendere la mano e riproporvi più canzoni di Daniela Pes e di Emma Nolde: quando Matteo Aschedamini ci ha proposto un racconto ispirato a una canzone dei Vintage Violence potevamo quindi dirgli di no? No (nel senso che gli abbiamo risposto sì), ed eccoci qui oggi a riparlare della band che arriva da quel ramo del lago di Lecco.
Ma prima presentiamo Matteo, conosciuto alla presentazione di un libro in quel di Milano e salito velocemente e con entusiasmo sul carrozzone della musica bella che fa la fame. Nato a Crema nel 2004, legge tutta la letteratura che riesce a far entrare fisicamente ed economicamente in casa e crede nel matrimonio tra prosa e poesia. Cerca di imparare il russo sia per ottenere la laurea che per poter leggere in lingua le poesie di Robert Roždestvenskij, e fin qui lo sforzo non lo ha soverchiato. La sua canzone preferita è The adults are talking dei The Strokes ma il suo cuore e il suo Spotify battono in particolare il ritmo delle canzoni di Johnny Cash. Nella vita, oltre alla laurea, ha l’obiettivo di scrivere libri pazzi tenendo fede alla parola di Gianni Rodari brillantemente esposta in La grammatica della fantasia, e noi da insider sappiamo di almeno un paio di suoi progetti che sembrano molto succulenti: tenetelo d’occhio, e in attesa d’altro leggetevi questo suo racconto su Topsy Kretts.
Che dire invece dei Vintage Violence (Nico Caldirola alla voce, Rocco Arienti alla chitarra, Roberto Galli al basso e Beniamino Cefalù alla batteria) che non abbiamo già detto qui qualche anno fa? Molto in realtà, perché sono passati quasi cinque anni dal racconto natalizio che ci ispirò la loro Natale lavavetri e al conto di tre album (Psicodramma, autoprodotto nel 2004, Piccoli intrattenimenti musicali, uscito nel 2011 per Popolar, e Senza paura delle rovine, con il quale nel 2014 iniziano il percorso che ancora li lega a Maninalto!) e un Ep (Cinema, 2007 per Goodfellas) si sono aggiunti Mono (2021, e non ci eravamo fatti sfuggire l’occasione di parlarne) e Violenza primordiale (2022), best of democratico in cui le canzoni sono state scelte direttamente da noi fan. Quel “noi” sta ovviamente a indicare che se cercate obiettività da parte nostra sui Vintage Violence non la troverete, o almeno troverete la sincera convinzione che di band così unite, impegnate politicamente e socialmente, capaci di unire testi intelligenti e un’attitudine live esaltante dovrebbero essercene di più (e un po’ cerchiamo di segnalarvele proprio qui su Tremila Battute, e farvele ascoltare nella playlist dedicata sul maledetto Spotify), e se questo commento vi pare una sviolinata non possiamo fare niente per convincervi del contrario, a parte invitarvi a una delle date del loro tour che partirà il 23 gennaio dalla Santeria di Milano. Noi saremo lì, ad ascoltare le loro canzoni (fra cui Il nuovo mare, Sono un casino e Contro la società securitaria, singoli usciti fra il 2023 e il 2025) e a pogare, e non avremo bisogno di spiegarvi perché da anni si definiscono “una via di mezzo fra De André e i NOFX“.
Metereopatia è la seconda traccia di Senza paura delle rovine, una delle loro canzoni più amate che ai concerti non può mai mancare (e il cui video Cesare Cremonini ha copiato spudoratamente, vale la pena di ricordarlo), in cui attraverso immagini futuristiche e semicatastrofistiche di navi interstellari pronte a portarci altrove e la nuova sede del Vaticano spostata sulla bocca di un vulcano la band esprime alla sua maniera tutto il disagio che la Lombardia è capace di esprimere nel suo lato più securitario e improntato alla fatturato (sarà un caso che proprio a loro sia spettata la cover di Marte dei Punkreas, all’interno della versione “revisited” dell’iconico Paranoia e potere della band varesotta, con la sua strofa “l’importante è il fatturato e non la vita”?). I protagonisti del racconto di Matteo questo disagio lo affrontano a modo loro, sfrecciando in macchina nella nebbia bergamasca fra una nutria da investire, un cartello stradale da rubare e qualche colpo da sparare con la scacciacani in piena campagna, mentre dall’autoradio la voce di Nico continua a scandire il mantra “Metereopatia, portami via dalla Lombardia”: potete entrare in questo frammento della loro vita andando più in basso, subito dopo la canzone che ha ispirato queste vicende e i miei auguri di buon ascolto e buona lettura.
Se volete ascoltare questo e tutti (o quasi) gli altri brani che hanno ispirato i racconti di Tremila battute ora potete farlo tramite questa comodissima playlist su Spotify: in attesa di trovare un canale che ricompensi davvero l* artist* accontentiamoci di quel che passa il convento e ascoltate, condividete, supportate (e se avete canali alternativi suggeriteli nei commenti).
Scarica la fanzine di Tremila Battute: numero Zero, numero Uno, numero Due e numero Tre.
La Pimpa è di Bergamo, di Matteo Aschedamini
Il Bastardo guida ondeggiando.
Sfreccia sulle strade sterrate fuori Bergamo, scende verso Lurano, giù in una coltre di nebbia che si divora costellazioni di fabbriche squadrate e cascine. Il Bastardo ci vede come un falco, di tanto in tanto spegne di colpo le luci della Punto per prenderci per il culo.
“Non fare il coglione!”
Luci accese, cascine di nuovo tagliate in solitari muri di mattoni rossi e cancelli di Vattelapesca I.N.C. Una torretta di guardia, sulla cima nidi con parlamenti, senati e tribunali di aironi. Nulla di visibile per via della nebbia, salvo le carogne delle nutrie, creature di Dio sprovviste del senso del pericolo stradale.
Burro siede sul sedile del passeggero. Ha in mente di fare un colpo: furto di segnaletica stradale.
La zona è già stata setacciata. Il Bastardo ha circumnavigato gli incroci dei soliti posti di blocco, infilandosi in una strada di campagna. Prima, però, andiamo a sparare qualche colpo con la scacciacani. Burro la tira fuori dal vano della portiera e la carica.
“Lo fai tu il primo colpo?”
Il Bastardo esce dalla macchina. La terra è fangosa e fredda. Il cielo è freddo e fangoso. Ondeggia mentre allunga il braccio verso le stelle.
“Attenzione Saturno, adesso ti colpiamo!”
“Mi ha sfondato un timpano, cazzo!”
Poi la macchina riparte, la strada si intreccia coi canali scavati dalle nutrie. Il Bastardo tenta di accopparne una, la nutria salta quando mancano solo istanti prima che il muso della Punto la spinga a terra, spiaccicandola.
Burro ha puntato un dare la precedenza fuori da un ristorante. Il Bastardo si getta all’attacco, trascinandosi dietro la fedele pinza, Burro parte al galoppo dietro la sua ombra. Raggiunto il cartello lo scuotono energeticamente, poi il Bastardo fa leva con il suo peso e Burro strappa con le pinze un tocco di ferro che teneva la sbarra immersa nel cemento. L’asta su cui è adagiato si spezza e il cartello cade fra le mani del Bastardo.
In silenzio volano verso la Punto, gettano il cartello nel baule e lo coprono con un telomare della Pimpa (La Pimpa è di Bergamo!).
Poi andiamo al Mc a mangiarci un panino.
Siamo lì da mezz’ora quando il Bastardo si alza di colpo, si tiene le guance fra le mani, poi si schiaffeggia.
“Cazzo! Mi sono dimenticato le pinze. Sono di mio padre, devo andare a riprenderle.”
La nebbia non si è alzata, serpeggia bassa e intensa come una gastroenterite. Il Bastardo risale Pognano, Lurano, Brignano, scaraventandosi nel vuoto cosmico.
Siamo a poche centinaia di metri dal ristorante cinese, praticamente arrivati; vedo il palo orfano di cartello, poi i fanali spiegati di una macchina che non rallenta mi riempiono gli occhi. Una capriola su un fianco, un’altra ancora. I vetri sparigliati per terra, le pinze poco distanti.
Nell’abitacolo in soqquadro il Bastardo non c’è. Si è catapultato fuori e corre con la scacciacani in mano.
Riesco a intravederlo mentre grida “Eureka!”, alza le mani con la scacciacani in una e le pinze nell’altra e penso: Metereopatia…Portami via dalla Lombardia…
Ti è piaciuto questo racconto/articolo? Segui le pagine Facebook e Instagram di Tremila Battute!