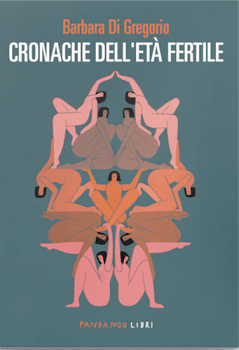Come penso capiti a molt* lettor* forti ho un serio problema con l’accumulo di libri. Peggiora col passare degli anni e in determinati periodi (la primavera specialmente, fra Book Pride a Milano e il Salone del libro a Torino) arriva a picchi di trenta e passa libri in arretrato. Molti vengono recuperati piuttosto velocemente, ma una categoria in particolare di solito finisce a fare la polvere più degli altri: quelli voluminosi, perché oltre che vittima dell’accumulo sono anche vittima della performance che mi spinge a leggere di più, sempre di più, anche se poi arrivò a fine mese e faccio fatica a ricordare ciò che ho letto. Così, nonostante una pandemia di mezzo, le seicentosessanta pagine de L’ospite d’onore di Joy Williams hanno dovuto attendere che mi prendessi una pausa dal mondo di un mese causa infortunio (a un pollice eh, mica mi sono scassato mezzo, ma comunque non piacevole) per essere lette, e cavolo non penso proprio che le dimenticherò così velocemente.
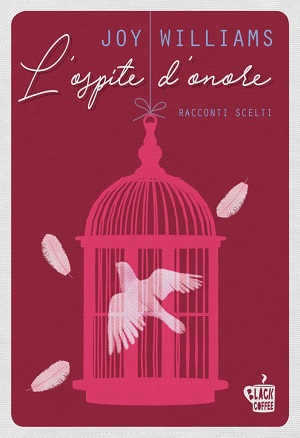
La pausa che mi sono preso (forzatamente) io è minore di quella che nel frattempo si è presa Black Coffee, la casa editrice specializzata in letteratura nordamericana che più di una volta ci aveva convinto con le sue scelte. L’editrice e traduttrice Sara Reggiani, complice la morte del padre (coinvolto a sua volta nella casa editrice), ha deciso pochi mesi fa di prendersi un anno sabbatico, avallata in questo dallo storico editor John Freeman che le ha detto in parole semplici “hai un ampio e bel catalogo, puoi concederti di lasciare tempo all* tu* lettor* di recuperare quanto lasciato indietro mentre tu recuperi le energie”. Il libro di Joy Williams, compendio quasi onnicomprensivo delle sue tre raccolte di racconti (Taking care del 1972, Escapes del 1990 e Honored guest: stories del 2004, mai tradotte in italiano) più alcune short stories apparse su riviste, è uno di quei libri che, nel caso non lo aveste già fatto, un* lettor* affezionato di Black Coffee (e della letteratura nordamericana in generale) dovrebbe recuperare, perché l’autrice scava nell’essenza più profonda degli Stati Uniti con una penna acuta e personale.
«Che tipa stramba» disse Helen.
«Chissà come gli sarà venuto in mente» disse Lenore. «Vorrei rivederla. E ucciderla».
«Anch’io» disse Helen. «Non scherzo».
«Anzi no, sarebbe troppo facile» disse Lenore. «Essere uccisi è un privilegio. A volte ci penso… a volte penso che vorrei che mi uccidessero. Così, dal nulla, senza avvertimento, né ragione. Non crederei a ciò che vedo. Sarebbe come non morire affatto».
Helen se ne stava lì nella sua vestaglia. Aveva freddo. In molti avevano scritto sulla morte. Nessuno aveva idea di cosa stesse dicendo, ovviamente.
«Sono stanca di parlare» disse Lenore. «Non mi va più. Sono stanca di pensarci. Perché dobbiamo pensarci sempre! Un filosofo una volta ha detto che la morte è la Grande Pensatrice. Pensa, dall’inizio della tua vita fino alla fine».
«Chi?» chiese Helen.
«Chi cosa?»
«Chi è questo filosofo?»
«Ah. Non me lo ricordo» disse Lenore. A volte Helen la faceva proprio sorridere.
L’ospite d’onore
Se dobbiamo ascrivere Williams a una corrente letteraria questa è sicuramente il minimalismo. Viene in mente Carver leggendo le prime storie della raccolta, col suo campionario di coppie fratturate che hanno l’alcol come punto d’unione e vite piuttosto anonime da sopportare più che da condividere. Non sono persone speciali quelle di cui parla l’autrice, e non sono quasi mai speciali i momenti in cui le tratteggia: un predicatore la cui moglie viene colta da una malattia senza nome mentre la figlia si dà alla macchia lasciando loro la nipotina da crescere; una coppia con le figlie avute da matrimoni precedenti che passano l’estate con uno scrittore che invita una donna diversa a settimana; un giardiniere che cerca di sgravarsi dal peso della catena karmica va incontro ad alcune disavventure. Nessun finale risolutivo, nessuna grande rivelazione all’orizzonte: Williams è brava a destreggiarsi in quelle vite, a cogliere momenti che dicano qualcosa di più dell* protagonist*, mantenendo sempre una certa fredda distanza ma evitando il grande pericolo che qualunque emul* volontari* o involontari* di Carver corre, ovvero quello di annoiare cercando di raccontare l’eccezionalità dell’anonimato.
Eppure ci vuole un po’ prima che Williams ingrani davvero, mantenendosi su un buon livello ma senza stupire per personalità: è dai racconti della seconda raccolta, Escapes, che si comincia a ballare davvero.
Lungo il corridoio ci sono diverse porte chiuse e dietro una di queste c’è Molly. Molly è la loro figlia viva. L’altra figlia, Martha, è morta da un anno. Martha era nata un anno prima di Molly. Ora hanno la stessa età. Martha si è strozzata con un pezzo di pane nella sua cameretta. Era mattino presto e si stava preparando per andare a scuola. Alla radio due dj che si facevano chiamare I Fiocchi di Mais chiaccheravano fra una canzone e l’altra.
La pattinatrice
Con La pattinatrice avviene uno scatto. Williams non si limita più a nascondere i traumi, a farli intuire tramite le azioni spesso bizzarre (quando non dettate da qualche dipendenza) dell* su* protagonist*: si prende il permesso di mostrare già tutto quello che c’è, e oltre a rendere i suoi racconti un campionario estremamente vivido di persone con un lutto alle spalle (mariti, mogli, figl*, genitor*, animali) riesce anche ad ampliare la sua narrazione, rendendo nel frattempo ancora più particolari le persone che animano le sue storie.
«Quando sono diventata abbastanza grande da capire qualcosa,» disse Argon «ho deciso che al mio fianco volevo un ambientalista o un appassionato di motori. Sono partita da questo. Alla mia prima manifestazione mi sono sdraiata in mezzo a una strada, in un parco dove avrebbero dovuto abbattere duecento alberi per fare spazio a un’area picnic. In molti si sono radunati a guardare. Quando è arrivata la polizia per portarmi via, una bambina ha detto: “Perché portano via quella ragazza carina, mamma?”, e allora ho capito che stavo facendo la cosa giusta. Dopo, ho partecipato alle manifestazioni con ancora più entusiasmo, sperando sempre di risentire quelle parole. Ma non è più successo».
«Si invecchia, tesoro» disse Irene.
«Anche gli appassionati di motori sono interessanti» disse Argon. «Ipnotici, quasi, ma solo quando parlano di motori».
Congresso
Congresso, tratto dalla terza raccolta di Williams Honored guest: stories, è forse l’apoteosi di questi tratti distintivi. La storia di Miriam, compagna piuttosto anonima di un professore di antropologia forense adorato da student* e concittadin*, accumula svolte narrative sempre più surreali che coinvolgono incidenti di caccia, triangoli amorosi, il rapporto simbiotico con una lampada fatta con le zampe di un cervo e il più famoso museo di animali impagliati senza che questo appaia mai troppo, riuscendo a mantenere un legame con la realtà nonostante dialoghi che finiscono nel nulla, o forse proprio grazie a quelli: l’abilità della scrittrice sta nel capire quali momenti cogliere, come metterli insieme, perché molti dei nostri discorsi sono pieni di momenti morti o inutili ma pochissimi avrebbero senso su carta.
Tramite questo scarto verso la surreale bizzarria delle nostre vite Williams riesce anche a divertire, il tutto mentre ci irretisce nella fuga di una malata terminale con la figlia minorenne di un’amica o ci illustra le dinamiche relazionali di un gruppo di madri di assassin* che si ritrova a vivere in appartamenti vicini. Non fraintendiamo, L’ospite d’onore non diventa mai un libro comico, e le risate le facciamo a denti stretti mentre ammiriamo come vite, relazioni e persino gli edifici vengono erosi dall’entropia: c’è però tanta partecipazione umana dietro, camuffata da quello sguardo freddo ed entomologico che caratterizza altrettanto il suo stile (Williams predilige la terza persona è sconfina raramente nella prima, con esiti altrettanto apprezzabili). Non tutti i racconti della raccolta sono capolavori, ma in seicentosessanta pagine non ne ho trovato uno brutto. Neanche uno. Se amate il minimalismo ma dopo Carver vi sembra tutto un “more of the same” date a Williams una chanche, anche se la mole vi intimorisce: vi troverete ad aspettare come me che qualche altra illuminata casa editrice (oltre a Black Coffee, che ha portato in Italia sia questa raccolta che il romanzo L’altro bambino, Nutrimenti ha pubblicato nel 2009 il romanzo I vivi e i morti) si metta d’impegno per far conoscere maggiormente questa grande scrittrice.
Ti è piaciuto questo racconto/articolo? Segui la pagina Facebook di Tremila Battute!
Scarica il numero Zero, il numero Uno e il numero Due della fanzine di Tremila Battute!