
So che è un’associazione difficile da fare, ma se ci si pensa un attimo di punti in comune fra Bojack Horseman, serie animata giunta da qualche mese alla conclusione dopo sei stagioni, e La regina degli scacchi, miniserie autoconclusiva di sette episodi, se ne possono trovare parecchi. Il più semplice e banale è il fatto che siano entrambe prodotte da Netflix, ma anche a livello di temi ci sono delle affinità: sia Bojack che Elizabeth Harmon, la scacchista interpretata da Anya Taylor-Joy, hanno un serio problema di dipendenze, per non parlare delle figure materne che ne hanno condizionato non poco la vita. Le storie dei due personaggi, cominciate in maniera simile, divergono però completamente analizzando il loro percorso e, soprattutto, il modo in cui le loro vicende finiscono, sintomatico dell’andamento delle due serie. Contando che sto per parlare di finali darò per scontate molte cose e, ovviamente, ci saranno spoiler, per cui se non volete rovinarvi l’esperienza tornate su queste pagine dopo averle recuperate.
La regina (incontrastata) degli scacchi

Se c’è una cosa che non è mai in dubbio, durante la visione de La regina degli scacchi, è che la protagonista riuscirà ad avere successo. La serie creata da Scott Frank e Allan Scott, pur girata con molto mestiere e abilità nell’orchestrare gli avvenimenti, fallisce proprio laddove dovrebbe essere più forte, cioè farci credere che la vittoria finale non sia scontata. Da quando Elizabeth mette la mano sugli scacchi la prima volta si contano ben poche partite in cui l’esito è veramente in bilico (la prima con il Benny Watts di Thomas Brodie-Sangster, e le prime due con il Vasily Borgov interpretato da Marcin Dorociński), guastando anche il realismo con cui le partite sono state simulate (fra i consulenti della serie compare il leggendario campione sovietico Garry Kasparov).
L’unico ostacolo fra Elizabeth e il successo è rappresentato da sé stessa, dalle sue dipendenze e dal fantasma della madre, una figura di cui sembra seguire profeticamente le orme in un percorso che porta verso la follia e la morte. Peccato che anche il lato autodistruttivo della protagonista sia in qualche maniera “annacquato”, lasciandocela vedere sì nel pieno di un processo di logoramento fisico e mentale (soprattutto dopo la seconda sconfitta con Borgov) ma negandoci l’esperienza della sua riabilitazione, che avviene sempre in maniera veloce e con pochissimi strascichi. Anche la sopra citata sconfitta con Borgov, quella che ci viene presentata con un flash forward proprio all’inizio della serie, serve solo a dimostrare che il cammino è in salita ma la posta in palio è assicurata: dopo una notte di bagordi come quella che ci viene fatta immaginare una persona normale faticherebbe a stare in piedi, figuriamoci giocare a scacchi, altro segno che le qualità della protagonista sono troppo sbilanciate per poter trovare un avversario degno di questo nome.
Le dipendenze e le nevrosi della protagonista vengono definitivamente sconfitte proprio prima dell’ultimo scontro, la sfida con Borgov nella sua Russia. Qui la serie perde secondo me il controllo dell’ambientazione, facendo reagire i personaggi in maniera poco realistica. Gli scacchisti russi ci vengono mostrati inizialmente come una squadra, giocatori che studiano e si allenano insieme, un particolare che Watts ci tiene a far notare a Elizabeth. Questo è storicamente vero, tanto che in alcuni campionati del mondo il loro fare squadra ha portato addirittura ad accuse di patteggiamenti fra i giocatori per favorire il migliore fra loro: fu il caso del Torneo dei candidati di Curaçao del 1962, dove Bobby Fischer (campione geniale dalla vita sregolata, probabile ispirazione per il personaggio di Elizabeth in quanto unico statunitense a laurearsi campione del mondo) accusò tutto il team russo di essersi accordato per patte veloci in modo da potersi concentrare meglio contro avversari non sovietici, favorendo la vittoria finale di Tigran Petrosjan.

Questo tipo di competizione scorretta non appare nella serie, e non sarebbe un problema se non fosse che la statunitense Elizabeth, in piena guerra fredda, non solo viene osannata dal pubblico (forse la novità di una donna che si fa strada in uno sport quasi esclusivamente maschile è più forte della sua appartenenza al nemico, facciamocela andare bene) e venerata dagli avversari subito dopo essere stati battuti (storicamente gli scacchisti non prendono così bene le sconfitte, anche escludendo dal novero il bizzoso Fischer), ma si permette anche di lasciare la scorta di un agente FBI preposto al suo accompagnamento (e fin lì incollato a lei come un francobollo) per farsi un giro da sola nella capitale del nemico, finendo a giocare con degli arzilli vecchietti russi sotto la neve dopo essersi laureata campionessa (grazie anche all’aiuto di tutti i suoi amici riuniti insieme che la chiamano la sera prima del grande scontro). Un finale esageratamente trionfale, evitabile, ma in fondo affine a quello che è stato il percorso della serie: come dicevo all’inizio, la vittoria di Elizabeth non è mai stata in discussione, tanto vale prendersi la libertà di farle violare protocolli di sicurezza fin lì ferrei che tanto la credibilità è già stata compromessa lungo la strada.
Bojack Horseman, il mezzo cavallo più amato\odiato d’America
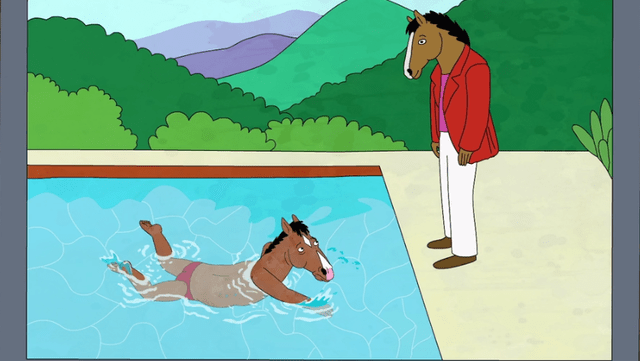
C’è un punto, nella prima stagione di Bojack Horseman, in cui il protagonista si mette a leggere la biografia che ha commissionato a Diane Nguyen. In italiano il titolo del libro è stato tradotto letteralmente come “Un mezzo cavallo”, ma è molto più interessante andare a vedere cosa significa il titolo della versione inglese: One trick pony gioca infatti sulla natura equina del protagonista, ma soprattutto dice molto di lui, un’artista che ha saputo fare solo una cosa. Già dalla prima puntata in fondo Bojack ci viene presentato come un fallito, di successo certo ma ben lontano dalla fama che pensa di meritare (ottenuta con una sola sitcom all’attivo, Horsin’ around, il suo “one trick”), e tutta la serie non farà altro che seguire le sue vicissitudini alla ricerca dell’amore del pubblico, un obiettivo che pensa di meritare tanto quanto cerca di sabotarlo con atti di vero e proprio masochismo.
Mai serie è riuscita meglio a coniugare il divertimento col dramma più cupo. Iniziando a vedere Bojack Horseman ci si aspetta solo le risate, magari anche stupide e volgarotte, ma a fianco di queste emergono sempre di più situazioni che coinvolgono morte, depressione, dipendenza e chi più ne ha più ne metta. Variando il tono di puntata in puntata e mescolando sapientemente i comprimari, dal super ottimista Mr. Peanutbutter alla gatta in carriera Princess Carolyn fino all’ingenuo coinquilino Todd Chavez e alla ghostwriter complessata Diane Nguyen, il creatore della serie Raphael Bob-Waksberg va sempre più a fondo delle complessità di ogni personaggio e soprattutto di Bojack, un protagonista per cui non si sa se tifare o meno contando che distrugge tutto ciò che trova sul suo cammino. Waksberg, in un fantastico episodio intitolato Stupido pezzo di merda, ci fa entrare letteralmente nella testa del cavallo, visto che per tutta la durata saremo accompagnati dai suoi pensieri mentre combina disastri a destra e a manca.
Se la freccia de La regina degli scacchi è perennemente direzionata verso l’alto, con qualche lieve o drastico calo a cui si associano altrettante repentine risalite, quella di Bojack Horseman è un saliscendi continuo, un alternarsi fra la speranza che il protagonista abbia finalmente il suo riscatto e quella che si inabissi completamente, smettendo almeno di infliggere (ed infliggersi) dolore. Ogni passo verso la redenzione porta sempre a un ritorno ai vecchi vizi, e quando anche Bojack ci mette dell’impegno sono le circostanze che sembrano congiurare contro di lui: arrivati agli ultimi episodi la freccia comincia a puntare inesorabilmente verso il basso, lasciandoci intravedere un finale amaro che, per alcuni, sarebbe stato quello ideale.

Non è andata però così. Contro ogni previsione Bojack si salva per un pelo dalla morte (l’ultima puntata si apre proprio con un’encefalogramma piatto, salvo farci poi vedere che a morire è il personaggio di Horsin’ around e non il cavallo in carne e ossa), negando a chi si aspettava un finale tragico la sua soddisfazione, mentre allo stesso tempo delude le aspettative anche di chi sperava in un finale positivo, visto che a Bojack viene inflitta una condanna a 14 mesi di carcere. Un finale che non soddisfa nessuno è esattamente quello più coerente per una serie del genere, che rifugge dal facile contentino verso chi esigeva una chiusura definitiva: nella vita reale non tutte le storie finiscono come dovrebbero, e che Bojack sopravviva nel mezzo del guado, ancora irrisolto, è quanto di più realistico ci sia. L’ultima inquadratura, dopo che Diane dice “qualche volta la vita fa schifo e poi continui a vivere”, è su lei e Bojack intenti a guardare le stelle, in evidente imbarazzo, senza più niente da dirsi: l’anticlimax definitivo, assolutamente perfetto.
La regina degli scacchi, tratta da un romanzo di Walter Tevis, è nata come miniserie ma potrebbe avere un seguito, frutto del successo ottenuto da pubblico e critica. Bojack Horseman, nonostante gli stessi strali, è stata chiusa da Netflix anche se gli sceneggiatori avevano idee per proseguire. Questo cosa ci dovrebbe insegnare? Date un finale ben definito alle vostre storie, possibilmente positivo…ma ricordate che non c’è miglior soddisfazione dell’avere successo remando contro ogni cliché.
Una opinione su "Confronti improbabili: cosa ci dicono i finali de La regina degli scacchi e Bojack Horseman delle rispettive serie"