Ricordo abbastanza bene quando è avvenuto il mio primo incontro con la musica lo-fi. Era il 2009, collaboravo con Indie-zone e ricevere i dischi significava, se il disco era estero, ricevere nella stragrande maggioranza dei casi un file piratato: mi capitò in questa maniera di ascoltare e recensire il secondo album degli Wavves, ovvero Wavvves, che ascoltai chiedendomi continuamente “ma perché l’hanno registrato così di merda?” Lo stroncai, ignaro che quel modo di fare musica aveva già basi solide e storiche: dopo anni densi di altre esperienze sonore (e la sorpresa di trovare una canzone degli Wavves stessi, registrata decisamente meglio, all’interno del videogioco GTA V) oggi forse (forse) lo rivaluterei.
Non ricordo invece quale è stata la mia porta di ingresso nel mondo dei film brutti. Negli anni ne ho “collezionati” parecchi, dagli storici capolavori di Ed Wood a perle meno note (perlopiù carpite dal fornitissimo, ma ahinoi non aggiornato, archivio del sito FilmBrutti.com) come Il bosco 1 o Van Helsing – Dracula’s revenge, quest’ultimo “nobilitato” dalla partecipazione di un Coolio (sì, quello di Gangsta’s paradise) fattone in versione normale e sessuomane in versione vampiro, e potrei andare avanti ore a citarne perché il fascino dell’orrido, una volta che ti prende, diventa una droga.
Pur uniti da mezzi di produzione limitati, e da budget quasi sempre risicati, non avevo mai pensato che i due mondi potessero avere molto in comune, almeno prima di leggere Bassa fedeltà- Musica lo-fi e fuga dal capitalismo, scritto da Enrico Monacelli e pubblicato da Nero, e il didascalico Film brutti, scritto da Andrea Carobbio e pubblicato da Mimesis. Pur partendo da basi e ambizioni completamente diverse, i due libri si parlano attraverso quella che è una caratteristica imprescindibile sia per la buona riuscita di un album lo-fi che per la pessima riuscita di un film brutto: la sincerità dell* autor*.
Filosofia e sociologia del registrare “male”

A differenza mia, quando Monacelli ha ascoltato per la prima volta un disco lo-fi non se n’è allontanato con ribrezzo. Il periodo era lo stesso, giusto un anno più tardi (le età, invece, decisamente differenti: lui diciassette anni, io avevo appena scavallato la trentina), ma il disco invece era un po’ più vecchiotto: Knock knock, settimo album di Smog (moniker dietro cui si cela dietro qui si cela Bill Callahan), uscito nel 1999. Per Monacelli è in particolare la canzone Teenage spaceship a rappresentare un’illuminazione, sia per il testo che riusciva a racchiudere il disorientamento adolescenziale con cui lui stesso faceva i conti, sia per i suoni che accompagnavano quelle parole.
E c’era un’altra cosa che mi aveva colto alla sprovvista: la canzone suonava cruda e povera. Naturalmente avevo già ascoltato delle demo registrate male o di qualche gruppo punk scadente, ma c’era dell’altro. Il brano suonava grezzo in un modo incantevole e premeditato. La chitarra girava intorno a quei pochi accordi, tesi e disadorni, che sembravano rimbalzare sulle pareti di una piccola camera da letto. Era affilata e metallica, di fronte a tutto il resto della canzone, e ne usciva meravigliosamente maciullata. I sintetizzatori, subito sotto la chitarra, suonavano come un ossimoro davvero bizzarro: svettanti ma scadenti e impolverati. La voce di Callahan si adagiava su questo mucchio di detriti dorati mentre entrava in scena la batteria, con il suono di piccoli barattoli di latta recuperati in qualche angolo di una landa deserta. La cosa più sorprendente di tutto ciò era sicuramente che non si trattava di una fortunata coincidenza emersa da circostanze casuali o di una bellezza nata dalla morsa della pura necessità: si trattava di uno stile consapevole, una sorta di registrazione magicamente messa a punto da Callahan e dal suo produttore, Jim O’Rourke. La canzone non finisce semplicemente così. Era un’opera di rovina virtuosistica, fatta apposta per esplorare le potenzialità dei suoni in bassa fedeltà. Era bellissima.
L’ascolto di quella canzone è per l’autore il punto di ingresso per un genere/non genere sfaccettato e multiforme come il lo-fi, interpretato in mille maniere diverse ma accomunate dal rifiuto verso le produzioni ad alto budget per altrettante ragioni diverse, da quelle estetiche a quelle di libertà creativa. A queste ultime Monacelli aggiunge motivazioni sociali, consapevoli o meno, analizzando la carriera e i dischi di determinati artisti (e di una sola band di artiste, perché purtroppo anche questa storia musicale è perlopiù una questione maschile) attraverso le riflessioni di gente come Félix Guattari, Herbert Marcuse, Franco “Bifo” Berardi e l’immancabile Mark Fisher, sviluppando nell’arco di poco meno di duecento pagine non tanto una storia cronologica della musica lo-fi (per quanto ci tenga a fissare un punto iniziale, opinabile per sua stessa ammissione, nel disco Smiley smile dei Beach Boys) quanto un manifesto politico che vede in questo tipo di produzione artistica una critica alla società capitalistica.
R. Stevie Moore ha pubblicato più di quattrocento dischi nella sua vita. Il numero varia a seconda della fonte che si prende in considerazione. Probabilmente nemmeno lo stesso Moore è sicuro di quanti siano. E probabilmente ce ne saranno molti di più il giorno in cui lascerà questa terra. Ha realizzato così tanti album e progetti bizzarri che nessuno avrà mai il tempo di ascoltarli tutti, ma lo scopo non è mai stato quello di consumarli o venderli: sono stati realizzati al di fuori di qualsiasi logica di mercato, per godere della loro esistenza come la documentazione di un momento molto specifico di una vita molto specifica. Non esistono per diventare merce da scaffale, ma per la gioia di esistere e per amore dell’esistenza, quasi come fossero figli di una compulsione
Uno dei pregi di Bassa fedeltà è quello di non limitarsi ai “grossi” nomi della scena, perché per un Daniel Johnston che è stato toccato per un breve periodo dalla luce dei riflettori (anche grazie, lo scopro qui, ai miei adorati Butthole Surfers) ci sono molti altri nomi che invece sono rimasti nell’ombra, seguiti da un piccolo gruppo di accolit* affascinat* dai loro mondi bizzarri e totalmente fuori mercato. Nomi come R. Stevie Moore, wannabe rockstar dalla carriera ultradecennale e alfiere del “do it yourself”, le algide Marine Girls, la cui carriera è durata solo fra il 1980 e il 1983, Phil “Mount Eerie” Elverum (uno che da queste parti apprezziamo molto) e Mike “Perfume Genius” Hadreas e le loro sofferte parabole esistenziali e Ariel Pink con il suo suono che si alimenta di nostalgia e paranoia. Per ognuna delle loro estetiche Monacelli trova una porta di accesso sociologica tutt’altro che scontata, persino avventata, ma innegabilmente affascinante: ecco allora che la musica delle Marine Girls viene associata alle ricerche sulla fobia degli spazi oceanici dei Freikorps che portarono Hitler al potere (secondo il controverso studio di Klaus Theweleit Fantasie virili, pubblicato nel 1977, l’acqua rappresentava il duplice terrore della penetrazione e di tutte quelle persone che desiderano essere penetrate), il bizzarro mondo mistico di Johnston si collega al comunismo acido che Mark Fisher stava teorizzando prima del suo suicidio e il ritiro in mezzo alla natura norvegese attraverso cui Elverum ha realizzato il disco Dawn, affine a prima vista alla genesi del Walden di Henry David Thoreau, viene associato più a Walter Benjamin.
Il catastrofista marxista Walter Benjamin ha scritto che《Marx dice che le rivoluzioni sono le locomotive della storia. Ma forse le cose stanno diversamente, forse le rivoluzioni sono un tentativo da parte dei passeggeri di questo treno – cioè la razza umana – di azionare il freno》, e per Elverum la musica era, su scala minore, proprio questo: un freno di emergenza che attiviamo per bloccare l’esistenza di una realtà ingiusta. Autoprodurre un album significava, per Elverum, essere fedele a un’interzona selvaggia, sia psichica che fisica, in cui un’uscita dalle costrizioni e dai vincoli è ancora possibile e auspicabile. Uno spazio in cui, attraverso una critica pratica e spietata dell’esistente, si possono esprimere e praticare nuovi modi di vivere, amare e morire, anche se senza garanzie o forme fisse a cui aggrapparsi. La gioia e il terrore della critica.
È anche una storia di contraddizioni quella del lo-fi, fatta di paradossali aspettative di successo, inquietanti amori oltre il limite dello stalkeraggio e, nel caso di Ariel Pink, un viaggio contro tutto e tutti nel mondo del complottismo. Forse le associazioni di Monacelli sono esagerate, forse l* artist* di cui sono narrate le gesta non si ritroverebbero in queste analisi, ma il lavoro compiuto in Bassa fedeltà fa riflettere sui modi in cui possiamo tentare una fuga dal capitalismo perlomeno ideologica, magari guardando anche verso le nuove leve della musica lo-fi che l’autore, attento alle nuove forme di espressione, elenca nell’ultimo capitolo del suo saggio che certifica una volta di più le capacità della casa editrice Nero di intercettare quella linea di congiunzione che ancora resiste fra musica e politica.
La bruttezza come forma di sincerità
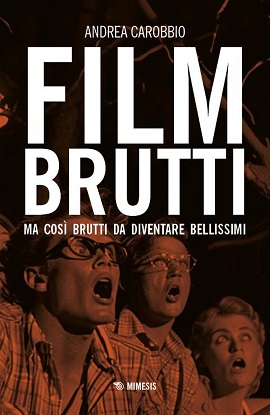
Nel suo Film brutti (sottotitolo: Ma così brutti da diventare bellissimi) Carobbio ha ambizioni sicuramente minori. Folgorato sulla via di Damasco dalla visione di The room, il capolavoro trash di Tommy Wiseau sulla cui lavorazione James Franco ha basato The disaster artist (che, a differenza della pellicola ispiratrice, si è portato a casa anche qualche premio prestigioso: ne avevamo parlato qui), l’autore del libro è stato risucchiato dal fascino dell’orrido nella sua più pura essenza, quella stessa che portava me, mio fratello e un nostro amico a organizzare saltuarie visioni collettive dei “capolavori” recensiti peggio dal già citato FilmBrutti.com: quella dove la bruttura è totalmente involontaria, e pertanto soffusa di una sorta di ingenua e stramba genialità.
Ciò che rende davvero affascinanti queste pellicole è che rappresentano un viaggio di sola andata nella psiche dei loro creatori. Aprono uno squarcio sulle vite di persone senza talento e perlopiù senza alcuna preparazione che, nonostante i palesi limiti imposti dalle proprie capacità e da budget spesso risicatissimi, semplicemente se ne fregano. Ma che vengano mossi da un’ambizione sfrenata e infantile, o da un egocentrismo esasperato o ancora da un’ottusità che rasenta l’idiozia, non possiamo che ammirarli. I loro film sono monumenti alla resistenza. All’ambizione sconsiderata. Alla frustrazione. Al fallimento. All’amore incondizionato e illogico per l’arte cinematografica. Ci raccontano di quanto sia dannatamente difficile riuscire a fare, a essere ciò che si vuole nella vita. Ed è per questo che è impossibile non amarli.
Il libro è composto da un elenco di schede su alcune delle peggiori pellicole prodotte negli ultimi cinquant’anni di cinema, soprattutto megli Stati Uniti ma sconfinando anche in Italia e persino in Turchia, con il delirante 3 Dev Adam che mette in scena, in barba a una ancora notevolmente fallace politica di protezione del copyright, uno Spiderman apocrifo e psicopatico che lotta contro un Capitan America di poco più realistico e… Il luchador messicano El Santo. Nessuna analisi sociologica, ma una linea ben precisa: evitare i nomi più famosi del panorama trash, come i già citati Wood e Wiseau, e concentrarsi sulle pellicole involontariamente brutte, escludendo dal novero le produzioni volutamente trash della Asylium (quella di Sharknado, per intenderci) e della capostipite di questo “genere”, la benemerita e immarcescibile Troma.

Il fascino di un libro del genere è quello di scoprire aneddoti gustosissimi sul dietro le quinte dei disastri annunciati mentre si andavano formando. Il misconosciuto (e italianissimo) Alien 2 – Sulla terra (non denunciatelo alla 20th Century Fox: nel 1980 Alien non era ancora un marchio registrato, e il regista e produttore Ciro Ippolito ha vinto la causa intentatagli), con i soldi del budget spesi in auto costose e col suo mostro fatto con la trippa, lo scippo di una catenina a Napoli da cui la vittima prende spunto per creare il delirante La croce dalle sette pietre (sottotitolo non ufficiale: L’uomo lupo contro la camorra), il volontario schianto di Carnosaur nell’uscire un mese prima di Jurassic Park (unica concessione alla bruttura consapevole: a produrre c’era Roger Corman, re mida delle pellicole a basso budget che nella sua carriera ha tenuto a battesimo gente come Joe Dante, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e Jack Nicholson) e l’incredibile motivazione per cui il protagonista di Samurai cop ha i capelli lunghi in alcune scene e un’imbarazzante parrucca da donna in altre (spoiler: il regista Amir Shervan aveva dimenticato di girare un buon cinquanta per cento del film, e nel frattempo l’attore Matt Hannon si era tagliato i capelli). Ciò che invece non può riuscire a fare Carobbio, con consapevolezza dell’autore stesso, è restituire su carta la bruttezza di certe scene, come quando gli orribili gallinacci in computer grafica di Birdemic: Shock and terror entrano in scena dopo quarantacinque minuti di noiosissima povertà creativa e di mezzi (il regista James Nguyen, totalmente immerso nel suo culto per Alfred Hitchcock, faticherà molto nel capire perché la gente ridesse invece di essere terrorizzata dal suo film), o come quando cerca di restituire l’improbabilità di alcuni scambi di battute di Megaforce, un film dalle ambizioni non meglio specificate che uscì al cinema nello stesso giorno di La cosa e Blade runner e floppò come loro a causa dello strabordante successo di E.T. pur divenendo, come gli altri due ma per motivi diametralmente opposti, un cult.

Ci sarebbe da parlare anche di Neil Breen, una sorta di involontario David Lynch dei poveri (su cui anche I 400 Calci hanno realizzato una retrospettiva), del flop imbarazzante di Dreamland – La terra dei sogni (guardatevi il trailer e ditemi se non sembra fatto da Maccio Capatonda), dell’eccezione (meritevole?) rappresentata dalla serie The lady di Lory Del Santo, ma non voglio togliervi la sorpresa di scoprire tutte le chicche (dis)gustose contenute nel libro. Carobbio ha la penna ironica al punto giusto per affascinare col suo racconto, anche se la conclusione delle sue retrospettive sembra spesso troppo veloce: trova però il perfetto anello di congiunzione con il saggio di Monacelli a pagina 90, attraverso il pensiero del già citato Roger Corman, che è la citazione con chiudo questo articolo sperando di avervi invogliato ad entrare almeno un poco nel mondo della musica registrata male e dei film girati peggio.
Corman credeva fermamente che la creatività non dipendesse dai soldi. Lavorare con pochi mezzi, secondo lui, stimolava l’ingegno e la capacità di trovare soluzioni innovative. Per Corman, in sostanza, il basso budget era molto più di una strategia finanziaria: rappresentava una scelta quasi ideologica. I suoi film sono dichiarazioni di indipendenza creativa, con i quali intendeva promuovere la democratizzazione del cinema, l’innovazione attraverso la limitazione dei mezzi e una ribellione contro l’industria hollywoodiana tradizionale.
Insomma, fanculo il capitalismo, anche se ci siamo dentro.
Ti è piaciuto questo racconto/articolo? Segui la pagina Facebook di Tremila Battute!
Scarica il numero Zero, il numero Uno e il numero Due della fanzine di Tremila Battute!

Anche quest’altro post spacca, soprattutto nella parte finale.
"Mi piace"Piace a 1 persona