Per certi versi sono una persona semplice, e questa semplicità di fondo si è rivelata già anni fa quando dovevo scegliere cosa recensire nel mazzo dei dischi arrivati a Indie-Zone, basandomi solo su tre fattori: la cover, il comunicato stampa (se presente) e il nome della band/artista. Secondo voi, fra un cantautore e i primi dischi di Gazebo Penguins e Tiger! Shit! Tiger! Tiger! io cosa potevo scegliere? Sono una persona semplice, e i nomi strambi mi hanno fatto sempre venire voglia di approfondire la questione.
Questa semplicità si riflette anche nel modo in cui è stato concepito questo articolo, che invece di mettere insieme i migliori dischi che ho sentito nell’ultimo periodo o quelli che hanno un’impronta musicale simile si concentra sul nome: quando mi ricapita di unire una banda armata che risponde al nome di Ottone Pesante, Huge Molosses Tank Explodes e GodzillaSexBike? Non lo so, quindi pronti all’infornata di musica dai nomi grossi.
La guerra degli ottoni
Dopo un disco dai toni doom e un Ep che evoca il black metal (salvo confermarlo solo nella poltiglia sonora della title track) la brass metal band Ottone Pesante (che qui a Tremila Battute conosciamo bene) si getta nuovamente sul campo di battaglia, seguendo stavolta non un filone estetico ma concettuale. I sette brani di Scrolls of war (Aural Music) evocano infatti sia dai titoli che dalla musica immagini di battaglia, soprattutto nei brani più atmosferici. È impossibile non evocare lo scempio che rimane al termine di un conflitto nei contrappunti epici che costellano il magma tenebroso nella prima metà di Men kill, children die, ma da lì il trio tenta di risollevarci con tutta la drammaticità del caso aprendosi ad un’alba impietosa a furia di inserti di tromba e trombone processati fino a farli sembrare un grido angelico che, prendendo a prestito le parole di Sam Rockwell in un punto di Sette psicopatici, ci lasciano credere che “il cielo è abbastanza blu da far capire che potremo vivere in pace, prima o poi”.
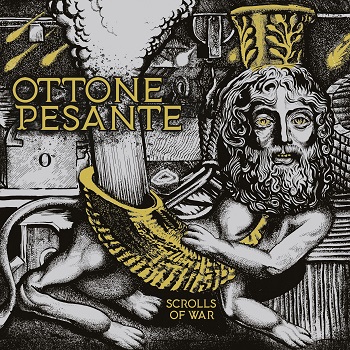
Brani come Teruwah o Sons of darkness against sons of shit (titolo che spiace non vedere tradotto) scatenano la verve più veloce e tecnica della band, e sono episodi efficaci e necessari all’interno di un disco vario, che alterna sul finale l’enfasi di Battle of Qadesh, inizio d’ispirazione jazz che lascia poi sfogare la splendida voce di Lili Refrain, e le sferzate diaboliche di Slaughter of the slains, dove impazzano invece le urla di Shane Embury dei Napalm Death. Il finale con Seven è un anticlimax, uno scivolare trattenuto che rende bene l’idea di cos’è la guerra: una consuetudine umana la cui epica si fonda sul nulla.
È quello che mi aspettavo dagli Ottone Pesante? Sì e no, perché li conosco abbastanza bene da non stupirmi di fronte alla loro formula ma allo stesso tempo riesco ancora a sorprendermi di fronte ai mille modi in cui riescono a variare il canovaccio: Scrolls of war è allo stesso tempo una conferma e un gioco al rialzo, perché di enfasi qui il trio ne profonde a piene mani.
Dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo
Gli Huge Molasses Tank Explodes hanno un nome così grosso che pensi subito a qualcosa di distorto e pesante, almeno fino a quando non scopri che deriva da un’alluvione avvenuta a San Francisco a inizio 900 o non ti metti ad ascoltarli, scoprendo che le suggestioni stoner che ti (mi) eri (ero) immaginato sono mitigate a furia di riverberi a livello sonoro, rimanendo però dense dell’effetto psicotropo tipico del genere. Vola più in direzioni cosmiche la band milanese, giunta con III (Tidal Wave Records) in maniera molto didascalica al terzo disco, con un approccio fra lo space rock e lo shoegaze che riesce a far apparire i brani più lunghi di quanto non lo siano realmente: niente lunghe cavalcate, tutto entro il limite dei sei minuti ma con un mood ripetitivo che incanta e una fantasia nei dettagli sotterranei che rende l’ascolto una scoperta continua.

Ho ascoltato troppa musica storta nella mia vita per dire che gli HMTE sono una di quelle band che colora fuori dai bordi, perché basta ascoltare una Tenous form a caso per accorgersi che, seppur mascherato molto bene, lo schema verse-chorus-verse è preponderante: all’interno della stessa canzone ci si accorge però di come sia facile rendere fresca la formula buttandoci dentro un’apertura di ritornello a base di feedback chitarristici sparati nell’aere fino allo spazio, dove portano in fondo la maggior parte delle suggestioni sonore della band. Ancorate al suolo da un lavoro della parte ritmica eccellente (i giri di basso in particolare entrano in testa senza uscirne più), lasciando libere chitarre e tastiera di colorare sì entro i bordi, ma ovunque e con tutti i colori possibili, la band milanese lascia l’infinitamente grande solo per gettarsi a capofitto nell’infinitamente piccolo, esplorando bucoliche e micotiche (nel senso dei funghetti allucinogeni) ambientazioni nella fantastica Distant gloves ed evocando spettri della Summer of love anche nell’andamento narcotico di Eerie light, che nel finale gioca la carta dell’accumulo e sovrasta le orecchie con un’assommarsi di distorsioni e riverberi.
Lungo gli otto brani di III gli HMTE si divertono anche a gettarsi in esperimenti riusciti come Indeterminate, voce e tastiera robotiche che accompagnate da una batteria drittissima fanno pensare per qualche secondo agli Air prima che arrivino le chitarre a far ascendere nuovamente fino all’assolo stellare che conclude il brano. Era quello che mi aspettavo dal loro nome? No, ma quanto vorrei essere sorpreso ogni giorno così.
Il lato discreto della bizzarria
Leggo GodzillaSexBike e nella mia testa si aprono connessioni col cinema più che con la musica. Mi viene in mente Faster! Pussycat! Kill! Kill!, il cinema exploitaion degli anni 70, senza un vero ragionamento logico ma che ci volete fare, la mia testa è quella che è. L’idea di una band che si diverte a grufolare nel confine fra esagerazione e trash si sfalda però già alla seconda canzone, attraverso una chitarra arpeggiata che fa da ottimo collegamento con l’intro di musica da camera (opera della European Recording Orchestra di Sofia, che collabora anche in altri brani), Sophia è un brano rock ben scritto, con le cose giuste al posto giusto, capace di farsi morbido quando serve e di graffiare con suoni abbastanza grossi quando vuole dare una sferzata alle orecchie dell’ascoltatore, con il plus delle due voci, una maschile e una femminile, che trovano un modo efficacissimo di armonizzarsi fra loro: è anche una dichiarazione d’intenti la seconda canzone del disco, che chiarisce fin da subito che i riferimenti musicali sono generici e non specifici, l’obiettivo puntato verso un modo di fare musica più che verso un suono.
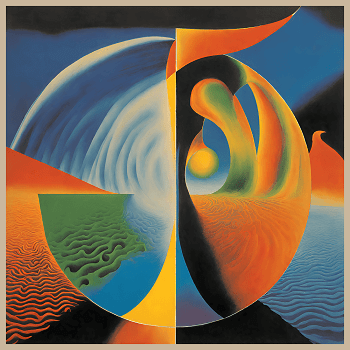
Hoobastank, Creed, Evanescense, Nickelback, questi i primi nomi che mi sono venuti in mente ascoltando gli undici brani di Right/wrong/place/time, disco d’esordio dei GodzillaSexBike dopo un paio di Ep e un recente cambio di formazione: band dal suono diverso e dal modo di scrivere diverso, che a un certo punto della loro carriera si sono però trovate a scrivere musica che sembrava pop coi chitarroni e che quando funzionava era una formula efficacissima ma ci voleva un niente perché sembrasse senz’anima. Purtroppo la stessa sensazione si avverte spesso negli undici brani del disco, troppo ancorato a un modo di fare musica che si basa sul binario strofa leggera/ritornello distorto: seguono questo canovaccio alla lettera ad esempio Signs of life e Borderline, rivitalizzate da un’ottima esecuzione tecnica e da armonie vocali (la cosa migliore del disco) efficaci finché le voci di Tommaso Benedetti e Gloria Crudo lavorano insieme, meno quando il primo resta da solo e si adagia sullo stereotipo del rocker dalla voce grezza anche quando non serve. Ci sono anche tentativi di variare il tiro, ma né l’indie ballabile di Love me so né il connubio col country da classifica di Wishes (The birthday song) riescono a dire qualcosa di originale.
Era quello che mi aspettavo? Ovviamente no, ma qua e là ci sono sprazzi di personalità: le strofe piacevolmente storte di Lullaby, il modo in cui Jenny da brano indie adatto a scatenarsi senza troppi pensieri rallenta e porta la festa verso atmosfere sognanti in cui l’orchestra torna a farsi sentire prepotente, momenti che lasciano pensare che poteva esserci molta più carne al fuoco in Right/wrong/place/time. È evidente che la concezione di musica mia e del sestetto brianzolo diverge in molti punti, e può essere che la loro formula li porti anche al successo: GodzillaSexBike mi pare però un nome più adatto ad attirare gli strambi come me che non le major ma ehi, se i Måneskin hanno insegnato al mondo come si pronuncia quella A col circoletto sopra chi sono io per porre limiti alla provvidenza?
Scarica il numero Zero, il numero Uno e il numero Due della fanzine di Tremila Battute!
Ti è piaciuto questo racconto/articolo? Segui la pagina Facebook di Tremila Battute!
